L’illusione di essere informati
L’ascesa degli opinionisti ha generato un flusso di commenti da parte di persone la cui legittimità a intervenire non è più basata su una competenza specifica, ma sulla notorietà mediatica
I problemi dell’informazione, in breve, non nascono solo dalle fake news, ma da un più generale modo di gestire giornali, trasmissioni, e altri prodotti che vede nell’analisi dell’attualità un formato che risponde a esigenze prevalentemente mediatiche
Filippo Riscica
Scopri i corsi di Appunti di Geopolitica
Ogni giorno diamo per scontato che leggendo i giornali, ascoltando una trasmissione o un podcast di commento politico ci informiamo.
In realtà non è scontato che leggere o seguire una trasmissione ci dia informazioni. E questo non soltanto nei casi più eclatanti di disinformazione, ma anche in casi che sono per molti aspetti migliori.
Il problema più evidente mi sembra il seguente. Per vari motivi, il discorso pubblico italiano è dominato dagli opinionisti. Persone che hanno acquisito una grande riconoscibilità e una precisa collocazione dialettica e che occupano spazi in talk show e quotidiani.
Questa cultura dell’opinionismo si basa, mi sembra, su una più ampia attitudine. Tendiamo ad attribuire autorità alla persona e non agli argomenti e alle analisi che porta per sostenere le sue opinioni. Semplificando molto: se, per esempio, Paolo Mieli sostiene una posizione, la sua autorevolezza non dipende necessariamente dalla qualità dell’argomento portato avanti, ma dal suo essere autorevole.
Queste figure sono abbastanza trasversali. Alcuni, come Massimo Cacciari, traggono la propria autorevolezza dal proprio passato accademico e politico. Altri, dall’essersi fatti le ossa, per così dire, nei dibattiti televisivi.
Indipendentemente dall’origine, però, c’è un punto cruciale: l’autorevolezza di una persona deriva dalla qualità degli argomenti che porta e dall’ambito in cui ha sviluppato la sua esperienza.
In certi casi, come con Paolo Mieli, l’autorevolezza è giustificata per quanto riguarda la divulgazione storica, ma il problema sorge perché, abbassando le difese intellettuali perché vediamo una persona autorevole in un campo, chiediamo a lui di parlarci di Gaza, dimenticando, forse, che conoscere i fatti del passato è cosa ben diversa e richiede metodologie diverse da quelle necessarie per l’analisi del presente.
Questo permette di definire meglio il problema: va bene assegnare autorevolezza alla persona che ha dato prova di fornire regolarmente contributi di qualità in certi ambiti, ma bisogna rimanere attenti e valutare a fondo l’argomento specifico quando queste persone sconfinano in altri territori.
Queste considerazioni fanno sorgere una domanda spontanea: perché la categoria degli opinionisti ha l’autorità per commentare qualsiasi cosa in tempo reale? Perché, per esempio, Andrea Scanzi, che nasce come giornalista sportivo, o Marco Travaglio, che nasce come giornalista giudiziario, hanno l’autorità per parlare di Covid, di guerra in Ucraina, di Palestina e di qualsiasi altro tema saliente?
Oggi voglio cercare di spiegare perché, nonostante l’ampio uso fatto da quotidiani e trasmissioni di opinionisti di professione possa farci pensare che ascoltandoli acquisiamo informazione, in realtà, nella maggior parte dei casi, non lo facciamo.
I problemi dell’informazione, in breve, non nascono solo dalle fake news, ma da un più generale modo di gestire giornali, trasmissioni, e altri prodotti che vede nell’analisi dell’attualità un formato che risponde a esigenze prevalentemente mediatiche.
Che cos’è l’informazione
Partiamo da una considerazione generale: che cos’è l’informazione?
Con questa domanda non intendo chiedere quali siano i prodotti dei giornali, delle trasmissioni televisive e dei podcast. Tutti questi prodotti mirano, o dovrebbero mirare, a fornire informazione. Che riescano o meno a farlo è il criterio con cui valutarli. Se il servizio che offrono fornisce informazione, allora il prodotto è buono. Se il servizio non fornisce informazione, allora non è buono.
Però, dire che l’informazione è il criterio con cui valutare certi prodotti non dice molto. Anche gli ascolti sono un metro di paragone. Ci dicono quando un prodotto è buono da un punto di vista economico, ma non ci dicono necessariamente che il prodotto è buono da un punto di vista informativo.
È più facile dire cosa non è l’informazione. Non è dare intenzionalmente notizie false. Non è dare notizie fabbricate. Questi non sono casi di informazione ma disinformazione.
È ancora facile dire quali sono i casi che, pur non essendo notizie false o fabbricate, non sono esattamente positivi. Dare notizie non verificate. Dare notizie non verificabili. Dare intenzionalmente notizie lacunose per fuorviare chi legge.
Dato quello che non è, si potrebbe essere tentati di dire che informazione è dare notizie vere. Magari aggiungendo che si forniscono giustificazioni a supporto: per esempio, fonti o analisi autorevoli.
Questa, però, sarebbe una concezione troppo ampia. Un programma che desse solamente notizie del tipo “il sole è sorto” o “gli oggetti cadono” direbbe cose vere e anche giustificate, ma che difficilmente sarebbero considerate informazioni.
Un’idea che sembra abbastanza intuitiva è che l’informazione dica qualcosa di nuovo, che riduca le alternative da considerare. In breve, l’informazione riduce l’incertezza.
Se apro un’app di notizie e leggo che il sole è sorto, questa notizia non ha ridotto la mia incertezza su ciò che è accaduto oggi. In tutte le alternative possibili rilevanti, il sole sorge.
Se apro l’app e leggo che è scoppiata una guerra mondiale, acquisisco moltissima informazione. Tra le varie alternative possibili ogni giorno, solo alcune prevedono lo scoppio di una guerra mondiale.
Questa idea intuitiva ha una lunga storia. Ne parlavano già John Locke e David Hume. Oltre a essere intuitiva, è stata studiata matematicamente. La nascita della teoria dell’informazione è una delle grandi conquiste scientifiche della prima metà del Novecento e deve molto a Claude Shannon, un matematico pressoché ignoto al pubblico italiano, ma a cui dobbiamo moltissimo.
L’idea che dare informazione sia fornire contenuti veri e capaci di ridurre l’incertezza permettendoci di concentrarci sulle alternative rilevanti è, dunque, intuitiva, supportata da una lunga tradizione e studiata matematicamente. Tutti fattori che la rendono di assoluto rilievo per definire il metro di paragone con cui valutare epistemicamente i prodotti mediatici.
Dunque, una proprietà che vogliamo da un buon programma, podcast o giornale è che riduca l’incertezza permettendoci di concentrarci sulle alternative rilevanti, attraverso notizie, analisi e commenti.
Gli opinionisti di professione
La gran parte dei prodotti informativi—trasmissioni, giornali, podcast—è strutturata intorno a un nucleo di persone stabili. Questo di per sé non è un problema. Avere una linea editoriale chiara se supportata da un lavoro ben fatto è una cosa positiva.
Inoltre, bisogna distinguere tra prodotti che danno spazio a interventi ben strutturati—giornali, riviste, siti web ben curati—e quelli basati su conversazioni spontanee. Queste ultime sono più esposte a errori perché un testo scritto prevede un minimo di pianificazione e di revisioni, mentre una conversazione spontanea implica margini di errore più ampi.
Il problema di cui parlavo all’inizio nasce dal fatto che un numero ristretto di opinionisti influenti è chiamato a dare la propria opinione, spesso in tempo reale, su qualsiasi tema saliente.
Ora, non dico che i giornalisti o gli opinionisti non possano dare spiegazioni o fornire opinioni. Tutt’altro. Quando ci informiamo sugli ultimi fatti del giorno, investiamo una dose considerevole di attenzione.
Relegare tutto agli specialisti rischia di farci perdere la visione d’insieme, perché per farlo dovremmo offrire una panoramica completa delle opinioni sostenute dagli esperti.
Dato il tempo ridotto per commentare le notizie, non è realistico pensare di poter fare a meno di figure intermedie tra gli esperti e il pubblico. E neanche si può pensare che queste figure intermedie siano prive di autonomia intellettuale e debbano essere semplicemente divulgatori della ricerca fatta dagli esperti.
Il problema è un altro: non è ragionevole pensare che gli opinionisti siano una categoria che ha le competenze per dire cose significative su tutto in tempo reale.
Questo problema mi sembra essere esacerbato dal fatto che, in televisione e sui giornali, sono sempre le stesse persone a esprimersi negli anni su tutto.
Lo stesso fenomeno sembra che si stia replicando nei podcast, nei canali YouTube e nelle pagine social, in cui pochissimi vincono la competizione e diventano super influenti e, grazie a questa posizione dominante, iniziano a colmare ogni spazio.
Partiamo, quindi, dal problema generale. Quando un piccolo gruppo prende la maggior parte dello spazio dedicato al commento dell’attualità, vuol dire che pochissime persone daranno la loro opinione su una grandissima varietà di temi.
Per rimanere nell’ambito della televisione e dei giornali, persone come Scanzi o Travaglio sono intervenute sulla gestione del Covid e sulla guerra in Ucraina, sulla Palestina e sull’ultimo scandalo politico. Ognuno di questi temi richiede competenze specifiche.
Sicuramente, concedo che sia Scanzi sia Travaglio abbiano le competenze per affrontare temi riguardanti la politica interna. Però, dove trovano il tempo per sviluppare competenze così trasversali?
Per inquadrare il problema, è utilissimo usare un concetto approfondito nella ricerca filosofica contemporanea: lo sconfinamento epistemico.
Qualche anno fa, il filosofo Nathan Ballantyne ha pubblicato un articolo sulla rivista accademica Mind (la rivista, per intenderci, in cui Alan Turing pubblicò l’articolo sul test di Turing) in cui sosteneva che lo sconfinamento epistemico fosse un problema. Il problema è il seguente. L’autorità che deriva dall’essere un esperto è confinata all’ambito in cui si è maturata l’esperienza.
Per esempio, essere un premio Nobel per la fisica non garantisce che tu sia in grado di capire molto di politica. Nel momento in cui si sconfina in un ambito in cui non si è esperti, si perde di affidabilità.
Ecco, quindi, da dove nasce il problema. Affidandosi sempre alle stesse persone per affrontare qualsiasi tema, il rischio dello sconfinamento epistemico è altissimo.
Il problema è poi ingigantito da un ulteriore fattore.
Nel suo articolo, Ballantyne usava come esempi di sconfinamento epistemico il premio Nobel per la chimica Linus Pauling e Richard Dawkins. Dunque, persone che sono considerate ai vertici della ricerca nei loro campi e che hanno accesso a una fitta rete di relazioni accademiche che permette loro di avere una presa almeno di base anche su ambiti che non sono i propri.
Nonostante ciò, commettono sconfinamenti e, occupandosi di cose di cui non sono esperti, commettono errori grossolani.
Spero che si sia tutti d’accordo nel dire che nessuno tra gli opinionisti sia un esperto del livello di un premio Nobel o di un professore di Oxford. Questo, sia chiaro, senza nulla togliere al loro lavoro: sono giornalisti e il loro compito non è essere esperti in un ambito di ricerca.
Il problema, però, è che agli opinionisti vengono chieste analisi e spiegazioni. Quindi, vengono trattati come persone in grado di identificare i fattori rilevanti, avanzare ipotesi e spiegazioni su eventi anche molto complessi come una pandemia o una guerra.
In breve, vengono trattati come esperti che però non sono.
Quello che succede, dunque, è che delegando agli opinionisti il ruolo degli analisti, li si induce a diventare degli sconfinatori epistemici seriali.
Uniamo quindi i due punti: l’informazione come riduzione dell’incertezza e lo sconfinamento epistemico.
Prendiamo un esempio da una puntata recente di Otto e mezzo. Lilli Gruber chiede a Scanzi (a partire dal minuto 08:35) se crede che la questione palestinese possa nuocere a Giorgia Meloni. La risposta di Scanzi è in molti modi un ottimo esempio di risposta che non fornisce un’analisi informativa.
In primo luogo, dice che sa che le manifestazioni in supporto a Gaza non sposteranno di una virgola il comportamento del governo. Dire di sapere qualcosa è un’affermazione molto forte. Vuol dire escludere qualsiasi possibilità che le cose vadano altrimenti. Quali basi ha Scanzi per dire che sa che questo avverrà?
Poi, Scanzi prosegue esprimendo il suo sconcerto per la reazione molto tarda del governo. Questo è un punto su cui siamo tutti d’accordo. Ma quale informazione acquisiamo? Solamente che Scanzi è, come tutti, allarmato. Non c’è nella sua risposta neppure un tentativo di accennare a un’analisi.
L’unica cosa che viene trasmessa è l’espressione del disappunto.
Sia chiaro, io condivido appieno questo disappunto: è l’aspetto dialettico che non mi convince. Impiegare il proprio tempo televisivo solamente per esprimere disappunto senza fornire un’analisi o un approfondimento anche minimo è una mossa retorica che funziona per catturare il proprio pubblico, ma che non fornisce nessun tipo di informazione.
Il problema non riguarda solamente una mossa come quella di Scanzi, che sostituisce un’analisi che non può fare, con una semplice espressione di posizionamento.
Un altro caso in cui, nonostante non si faccia palese disinformazione ma neppure chiaramente informazione, è lo spazio dedicato al monologo di Travaglio in Accordi & Disaccordi. Travaglio ha a disposizione anche venti minuti, in cui può articolare un monologo sugli eventi rilevanti.
Anche tralasciando il fatto che Travaglio non è un esperto di geopolitica e relazioni internazionali, tema che al momento affronta spesso, in questi monologhi, Travaglio segue il suo stile, che è fatto di battute taglienti e sarcasmo.
Questo stile aveva probabilmente una funzione positiva nel momento in cui è esploso Travaglio––negli anni ruggenti del berlusconismo, quando Berlusconi controllava direttamente o indirettamente quasi tutti i canali televisivi, non c’erano i social, e usare il sarcasmo poteva servire per ridimensionare Berlusconi sul piano dell’immagine e mostrarne l’inadeguatezza in un caso in cui i fatti erano chiari.
Però, il sarcasmo non è una forma argomentativa valida, è una mossa retorica che toglie l’opinione oggetto di battuta dallo spazio argomentativo. Spazio argomentativo importantissimo quando i fattori da considerare sono molti e si mischiano con considerazioni di valore.
Quindi, fare un uso sistematico del sarcasmo avrà certamente una funzione mediatica––cattura l’attenzione––ma non necessariamente una funzione epistemica perché non migliora la qualità di quello che sappiamo/crediamo.
Questi sono chiaramente esempi ma sono esemplificativi di una tendenza generale, che coinvolge televisioni, quotidiani, e novità editoriali, in cui alle vere analisi e agli approfondimenti, sono sostituite le opinioni. E queste opinioni, a loro volta, sono selezionate guardando principalmente a fattori non epistemici: la riconoscibilità del personaggio, la sua adattabilità al format, il seguito che già possiede e che può contribuire a lanciare il contenuto.
Ora, sarebbe certamente ingenuo chiedere che tutti i mezzi di informazione smettano di valutare chi invitare sulla base di considerazioni commerciali.
È altrettanto ingenuo chiedere che siano invitati solamente esperti perché è molto difficile, e non sempre possibile, identificare l’ambito di esperienza rilevante. Inoltre, non è neanche detto che ce ne sia uno solo o che, in questo ambito ci sia un largo consenso sul problema. È poi rischioso perché, una parte del dibattito pubblico democratico è volta ad articolare posizioni comprensibili da tutti.
Non si può, in breve, sperare di trasformare lo spazio pubblico in un seminario scientifico.
Il punto è un altro. Da circa dieci anni, parliamo tutti di disinformazione, fake news ed echo chambers. Guardiamo agli aspetti chiaramente negativi del discorso pubblico, senza però valutare le molte zone d’ombra. Non dare spazio alle fake news e alle altre forme di disinformazione è certamente necessario. Questo, però, non basta.
Questo è il punto cruciale che voglio sollevare: anche quando si crede di fare buona informazione perché le notizie sono vagliate e non si dà spazio a fake news, ci sono altri rischi non meno dannosi per la qualità dell’informazione.
Uno di questi è lo sconfinamento epistemico legato al fatto che i maggiori mezzi di informazione cercano opinionisti prima che persone capaci di fare analisi e approfondimenti.
Cosa fare?
Non voglio avere la presunzione di dire come risolvere questo problema. Non avendo le competenze necessarie per sapere come gestire formati che devono occuparsi di qualsiasi tema che diventi saliente, commetterei lo sconfinamento epistemico che ho criticato negli opinionisti.
C’è però un punto trasversale che penso sia indicato dalla discussione sull’informazione e sullo sconfinamento epistemico.
Siccome il punto principale dell’informazione è concentrarsi sui fattori rilevanti, quando si analizzano eventi in tempo reale, basta chiedere (e chiederci) in che modo quello che viene detto riduce l’incertezza?
Se quello che viene detto è un’espressione di posizionamento completamente prevedibile—come sapere che Scanzi è indignato—probabilmente non è qualcosa che vale la pena dire, se non come inciso a una pur breve analisi.
Se quello che viene detto è un’analisi su un ambito di cui la persona intervistata non ha motivo di essere esperta, bisogna chiedere in che modo quanto viene detto riduce l’incertezza? Perché quello che si dice permette di concentrarci sui fattori rilevanti?
Domani su Appunti rispondo a Filippo, vista la rilevanza (per me) del tema che solleva. Stasera devo prima andare a compiere sconfinamenti epistemici in un talk show.
Stefano Feltri
Se pensi che quello che facciamo qua sia importante, regala un abbonamento ad Appunti a qualcuno a cui tieni
Su Appunti leggi anche
Reati senza corpo ma con un colpevole
In ambito giuridico c’è già chi si chiede se la macchina in questi casi non concorra nel reato, come una sorta di complice, ma almeno allo stato attuale della tecnica e del diritto, questa ipotesi deve escludersi perché la macchina, oltre a non essere un soggetto giuridico, non esprime una propria volontà e non è parte attiva del processo di distribuzio…
C’è vita oltre la destra
Per molto tempo si è creduto che la crisi dei partiti progressisti e di sinistra in Europa avrebbe inevitabilmente portato al rafforzamento delle destre più estreme e populiste, anti-europee, anti-NATO e anti-occidentali. In realtà, le ultime elezioni — comprese quelle europee — mostrano l’emergere di una nuova destra pragmatica e moderata, più realistica e meno ideologica: una destra che vuole adattarsi alle sfide del tempo
A cosa serve davvero la riforma della giustizia
Questa riforma costituzionale è una questione di potere, di dove fissare il punto di equilibrio tra politici e magistrati
Il nuovo potere cinese
La guerra commerciale certamente non fa bene alla Cina, perché riduce il principale motore economico del Paese: le esportazioni. Tuttavia, il confronto diretto con gli Stati Uniti — e il fatto che finora la Cina sia riuscita a gestirlo e persino a dominarlo — rafforza la posizione di Xi Jinping e del Partito Comunista.
La politica della denatalità
C’è una fortissima dimensione culturale in questo cambiamento. Molte vite si sono adattate alla mancanza di figli, e sempre più persone scelgono consapevolmente di non averne. È una questione generazionale: nelle nuove generazioni la vita senza figli è molto più concepibile che in passato
Fermare i deepfake
Tutti dovrebbero imparare a verificare, dubitare, approfondire e non è da escludere che il diffondersi dei deepfake possa far sorgere una nuova coscienza e risvegliare gli animi dal torpore in cui sono caduti dopo l’avvento dei social. Il paradosso, poi, è che probabilmente per riconoscere i falsi dovremmo usare sistemi di intelligenza artificiale










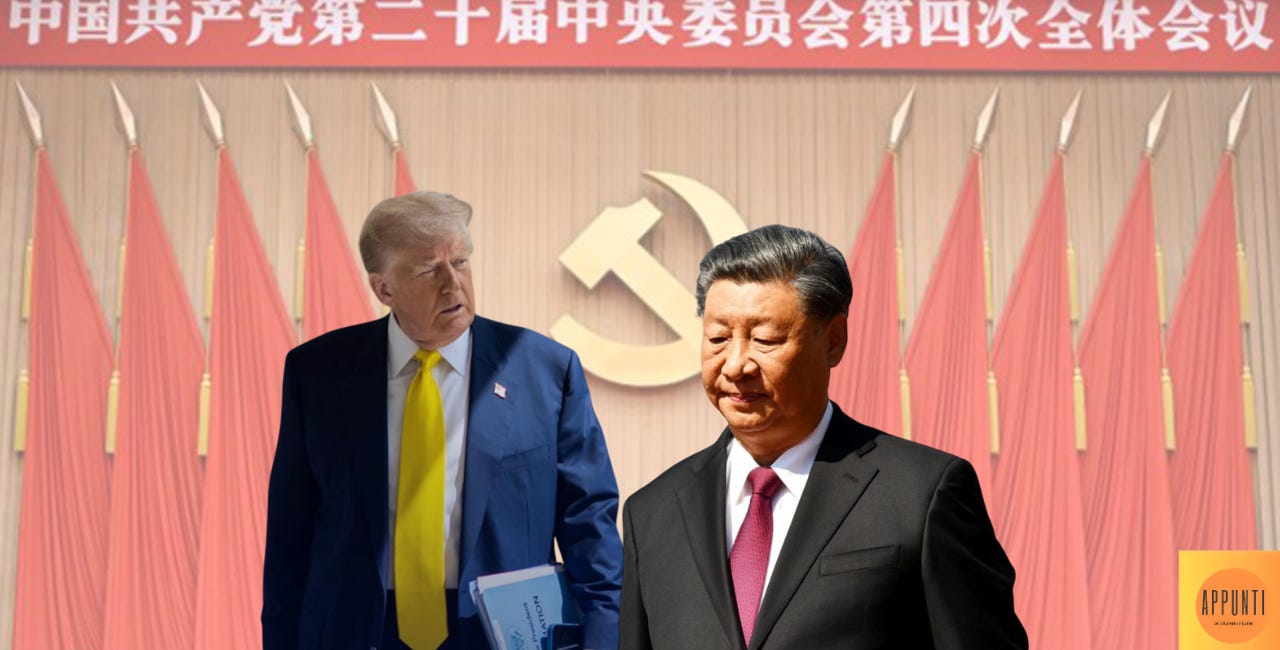




Ho apprezzato moltissimo l'analisi in particolare:
Il sarcasmo non è una forma argomentativa valida, è una mossa retorica che toglie l’opinione oggetto di battuta dallo spazio argomentativo. Spazio argomentativo importantissimo quando i fattori da considerare sono molti e si mischiano con considerazioni di valore.
Quindi, fare un uso sistematico del sarcasmo avrà certamente una funzione mediatica––cattura l’attenzione––ma non necessariamente una funzione epistemica perché non migliora la qualità di quello che sappiamo/crediamo.
Un saluto
Grazie Filippo Risica per questa bella e informatissima analisi.