Spaccare l’America
Questa prima fase del Trump 2 si inserisce in una lunga “guerra civile fredda” e in un progetto di mera conservazione del potere che richiede la distruzione dei nemici, veri o immaginari che siano
Interessi particolari si sono alleati con altri segmenti di potere, per poi entrare in sintonia con sentimenti profondi di una parte di elettorato americano. Il tentativo è quello di mantenere la presa sul potere per più tempo possibile, attraverso una terapia shock che indebolisca il più possibile l’avversario
Domani pomeriggio, 6 febbraio, vi aspettiamo al Centro studi americani di Roma con Mattia Diletti, alle 17.30. Torvate le info qui sotto. Parleremo del suo libro Divisi di Mattia Diletti per Treccani di cui aveva già scritto su Appunti (qui)
Non sono passate nemmeno tre settimane e Donald Trump ha deciso di avviare una blitzkrieg “da polarizzatore in capo”, con l’obiettivo di annichilire i nemici interni (costringendoli a inseguire un’enormità di fronti nel loro momento di massima debolezza), determinare il maggior numero possibile di trasformazioni costituzionali che possano favorire uno sbilanciamento dei poteri a favore dell’esecutivo, predicare una politica di potenza che ricorda più l’Ottocento americano che il Novecento, il vero ”Secolo americano”.
Questo intervento è diviso in tre brevi parti: si vuole ragionare sullo scenario di lungo periodo entro il quale si disegna la strategia trumpiana; discutere l’approccio trasformativo/eversivo del presidente Trump in materia istituzionale; sottolineare che, comunque vada, la politica e le istituzioni americane subiranno un’ulteriore ondata di delegittimazione del loro ruolo (a casa e nel mondo).
Manca una riflessione sugli Stati Uniti di Trump e il loro approccio in politica estera, oggi che si è conclusa l’epoca della Pax Americana disegnata nel dopo Guerra Fredda: si tratta di un tema che, da solo, richiederebbe un’ulteriore riflessione.
La guerra civile fredda
Diversi commentatori americani hanno descritto gli ultimi decenni come una guerra civile fredda.
C’è chi ha cercato di argomentare attorno a questa definizione in modo rigoroso, chi si è accontentato di evocarla per utilizzarne la forza espressiva.
Storici come Michael Kazin, e altri, descrivono i tempi lunghi di questo conflitto, che originano dalle contestazioni della guerra del Vietnam (il protagonismo politico di una nuova generazione), dei movimenti femministi e soprattutto dei diritti civili (la fine del secolo delle segregazione, cento anni dopo la fine dell’età della schiavitù).
A questi movimenti di sono accompagnati fenomeni trasformativi che hanno rafforzato la secolarizzazione della società, la sottrazione da parte di “Washington” del primato degli Stati su alcune politiche pubbliche, tanto nel campo della morale che del welfare (che hanno generato un aumento del ruolo del governo federale in linea con le vicende del New Deal), una distribuzione maggiormente plurale del potere, nonché degli spazi dell’immaginario collettivo (le minoranze che entrano nelle “stanze dei bottoni” e che conquistano visibilità pubblica).
Questi movimenti di lungo periodo sono stati contrastati da contromovimenti oppositivi, che hanno cercato di contrastare gli spostamenti di equilibri interni alla società americana.
In questo quadro, dagli anni Ottanta del Novecento lo Stato è divenuto il nemico pubblico numero uno, poiché esso è stato individuato come lo strumento che poteva ridurre quei “differenziali di potere” (un concetto sviluppato dal sociologo Norbert Elias).
Dietro l’incredibile muro della propaganda trumpiana e dentro le sue politiche, osserviamo come questo conflitto sia ancora in corso, ma anche come la società americana sia violentemente divisa e spaccata in due (è chiaro quale parte stia vincendo in questo momento).
Per capire il sistema della propaganda di Trump - l’architettura retorica che costruisce la cornice di senso di uno dei due campi della guerra civile fredda - chissà che non basti tornare alle teorie di Vladimir Propp sulla struttura delle fiabe: il racconto trumpiano presenta sempre la stessa morfologia.
Il “Malvagio” è sempre lo stesso, come ci è stato confermato dalle accuse di Trump contro le politiche di Diversità, Equità e Inclusività (DEI), colpevoli di aver provocato il disastro aereo del 30 gennaio 2025.
Non importa sia vero o meno - come per i gatti e i cani mangiati dai rifugiati haitiani durante la campagna elettorale, una hit dell’ottobre 2024 - ma c’è una parte di America che crederà sempre che ciò sia plausibile, perché è dentro il consueto “mindset” della guerra civile fredda americana.
Trump ha fatto di questa America la sua base elettorale: per essa produce miti e provvedimenti legislativi. Questi provvedimenti legislativi non solo difendono gli interessi del suo “popolo”, ma sono tesi a rafforzare il potere esecutivo, ovvero “la spada dell’eroe”.
La “spada dell’eroe”, a sua volta, protegge gli interessi economici del clan presidenziale e dei suoi alleati, come un vero “comitato d’affari della borghesia” del XXI secolo.
Questa è la vicenda della quale siamo spettatori: una partita di potere nella quale interessi particolari si sono alleati con altri segmenti di potere, per poi entrare in sintonia con sentimenti profondi di una parte di elettorato americano. Il tentativo è quello di mantenere la presa sul potere per più tempo possibile, attraverso una terapia shock che indebolisca il più possibile l’avversario.
La terapia shock
La terapia shock, al momento, consta di diversi obiettivi. Attraverso un uso sempre più massiccio di executive orders, in linea con tendenze di lungo periodo del sistema politico americano, Trump sta tentando di trasferire poteri all’esecutivo, anche attraverso modalità incostituzionali o di dubbia costituzionalità.
Un esempio su tutti è stato il tentativo di congelare la spesa federale, poi rientrato, per trasformare il controllo del budget in strumento di indirizzo politico (dal punto di vista costituzionale si tratta di prerogative che spettano al Congresso).
Si intende trasformare dall’interno la Costituzione reale degli Stati Uniti. Non si tratterebbe della prima volta - in momenti di crisi, come durante la Grande Depressione, l’esecutivo aveva trovato modo di espandersi e trasformarsi - ma la sfida sta oltrepassando limiti mai testati: tornare indietro è possibile tramite ritirate strategiche del presidente, interventi delle Corti federali, opposizione degli Stati e della società civile (soprattutto attraverso l’avvio di cause legali), opposizione del Congresso (il cui silenzio è lo strumento principe dell’avallo delle tecniche trumpiane: di lì passa la vera cessione di sovranità da un potere all’altro).
Questo fuoco di fila iniziale ha un impatto di breve periodo - nel caos massimizzare i profitti politici, e non solo quelli - e uno di tipo “trasformativo”. in questo senso, il Presidente, e il mondo che ruota attorno a lui, intende lasciare un’eredità, ovvero un potere esecutivo più forte e sottoposto a meno vincoli, dentro un quadro di ridimensionamento dell’intervento pubblico federale. Uno Stato più monocratico ma con un budget più ridotto, in primo luogo nelle politiche di welfare.
E qui il cerchio si chiude: se da un lato l’obiettivo è “meno Stato ma più presidente”, dall’altro le politiche sono disegnate a favore dei miliardari che finanziano Trump - ridurre le tasse, deregolamentare il settore finanziario, indirizzare gli investimenti pubblici verso determinati attori e settori dell’economia americana - e della base elettorale che ne ha sposato propaganda e ideologia.
Per esempio (un esempio fra mille), il vecchio sogno conservatore dell’abolizione del Department of Education, che significa devoluzione dei poteri agli Stati e abolizione delle politiche federali per l’istruzione (di fatto, politiche di welfare).
Questo Dipartimento - nella struttura attuale fu istituito da Jimmy Carter alla fine degli anni Settanta del Novecento - è una delle ultime appendici della cultura dell’espansione del ruolo dello Stato di matrice rooseveltiana: la sua abolizione è un colpo al cuore agli strumenti principe che il Novecento ha immaginato per ridurre le diseguaglianze sociali. E’ un pezzo di America che si vendica contro un altro pezzo di America.
Distruggere il nemico
Trump abbatte le casematte del nemico: in alcuni casi ci riuscirà, in altri il lavoro si fermerà a metà, in altri ancora ci saranno reazioni che lo impediranno, in altre arriverà un’autocensura dello stesso Trump (che verrà mascherata dalla comunicazione del Presidente e dal suo entourage); un giorno, presumibilmente, ci saranno un Congresso Democratico e un nuovo presidente che si darà premura di annullare decine di ordini esecutivi.
La sua volontà di comando, però, è anche il frutto di una debolezza strutturale: un Presidente che vince le elezioni con una maggioranza molto ridotta, uno dei pochi della storia che a inizio mandato possiede un indice di gradimento inferiore al 50 per cento, senza contare la maggioranza debolissima che il partito Repubblicano detiene al Congresso.
Mancano due anni alle elezioni di metà mandato - che solitamente premiano il partito di opposizione - e Trump mira a ottenere risultati maggiori di quelli raggiunti nel primo mandato.
Non è detto che non si aggrovigli nel suo stesso “caos strategico”, nel quale è accompagnato dalla figura di consulente-guastatore di Elon Musk, un ruolo mai visto fino a oggi nel sistema burocratico americano, ma anche da una Corte Suprema a maggioranza conservatrice che sarà chiamata a esprimersi su molte della fratture istituzionali praticate da Trump.
Comunque gli vada, è una presidenza che renderà l’America ancora più divisa e sempre più scettica rispetto al ruolo e alla legittimità delle istituzioni democratiche: questi anni di polarizzazione - insieme ad alcuni fallimenti strutturali del “Sistema America”, soprattutto a partire dalla crisi del 2007/2008 - hanno alienato ulteriormente gli americani rispetto alle loro stesse istituzioni.
Dopo Trump, chi riporterà alcuni milioni di americani a credere nella funzione di istituzioni comuni - o della democrazia come armistizio fra interessi - avendo essi scelto la strada del culto per il nuovo Re?
Come faranno a fidarsi delle proprie istituzioni americani che sono stati negletti per decenni, e che resteranno tali anche in questa fase? Chi placherà il desiderio di vendetta di chi sarà colpito da alcune politiche di Trump in modo diretto?
Chi ridarà credibilità a un Paese che colpisce i nemici interni ed esterni in modo erratico, provocando ulteriore risentimento diffuso e sfiducia nelle relazioni con un potere personalistico e inaffidabile?
I prossimi eventi
Roma, Centro studi americani: 6 febbraio
I seminari dello Spykman: C’è un’alternativa all’attuale ordine mondiale?
A grande richiesta tornano i seminari digitali dello Spykman Center diretto dalla firma geopolitica di Appunti Manlio Graziano. Dopo la serie sulle elezioni americane, ecco tre eventi dedicati alla crisi di un ordine mondiale, e alla possibilità che ne emerga un altro.
Potete registrarvi a questo link entro il 12 febbraio.
IEP@BU - Le regole europee per le piattaforme digitali nel tempo di Elon Musk
Nessun tema è più attuale dello strapotere delle piattaforme digitali e dei loro proprietari, a cominciare da Elon Musk. Negli ultimi mesi il professor Francesco Decarolis della Bocconi ha coordinato un gruppo di lavoro che ha cercato di dare una risposta alla domanda che tutti si fanno: le regole europee sono in grado di arginare Big Tech e al contempo promuovere l’innovazione? Come funzionano quelle attuali e come potrebbero essere migliorate?
Il rapporto dell’Institute for European Policymaking Rules That Empower: Turning EU Digital Regulation into a Catalyst for Innovation verrà presentato in anteprima nell’evento digitale dell’11 febbraio, dal professor Decarolis e dagli altri autori (modera Stefano Feltri).
Ne parliamo l’11 febbraio alle 18 in un evento digitale. Potete registrarvi a questo link.
Se vuoi sostenere Appunti, uno spazio di informazione e di analisi libero che si regge su lettrici e lettori, il modo migliore è regalare un abbonamento a qualcuno a cui tieni
Da leggere su Appunti
Sostieni il nuovo progetto di inchiesta
Perché abbonarsi
IEP@BU è su Substack!
L’Institute for European Policymaking della Bocconi è il think tank fondato da Mario Monti con il quale collaboro, che vuole portare la ricerca accademica nel dibattito europeo.
IEP@BU adesso è su Substack, potete iscrivervi qui sotto:
E ci sono molti eventi interessanti nelle prossime settimane, vi consiglio di registrarvi per partecipare (in digitale)
Le analisi di IEP@BU
IEP@BU Incoming Events
When Will Germany Be Back?
February 24, 2:30 PM-3:30 PM - ONLINE
The day after the federal snap election, we will explore the European consequences of the vote against the backdrop of Germany’s economic challenges.
In November 2024, a coalition government collapsed when Chancellor Olaf Scholz dismissed Finance Minister Christian Lindner, highlighting Germany’s ongoing struggle to balance its political ambitions, renewed security priorities, and stringent budget rules.
For the first time in decades, the European Union faces a dual leadership vacuum in Germany and France—two pivotal member states in EU politics.
Meanwhile, geopolitical and economic challenges continue to escalate: the war in Ukraine demands unwavering commitment from the EU's leading states and institutions, and Donald Trump’s return to power introduces uncertainty to global economic and multilateral governance.
Join us as we debrief the European implications of the German federal elections with Wolfgang Munchau and Diana Pieper.
Speakers:
Wolfgang Munchau is one of the foremost commentators on EU economic and political affairs. He is the director of Eurointelligence and the author of the recent book Kaput: The End of the German Miracle.
Diana Pieper is a Berlin-based journalist with Die Welt and an IEP@BU Media Fellow.
Stefano Feltri, IEP@BU communication advisor, will moderate the conversation.
Please, REGISTER HERE











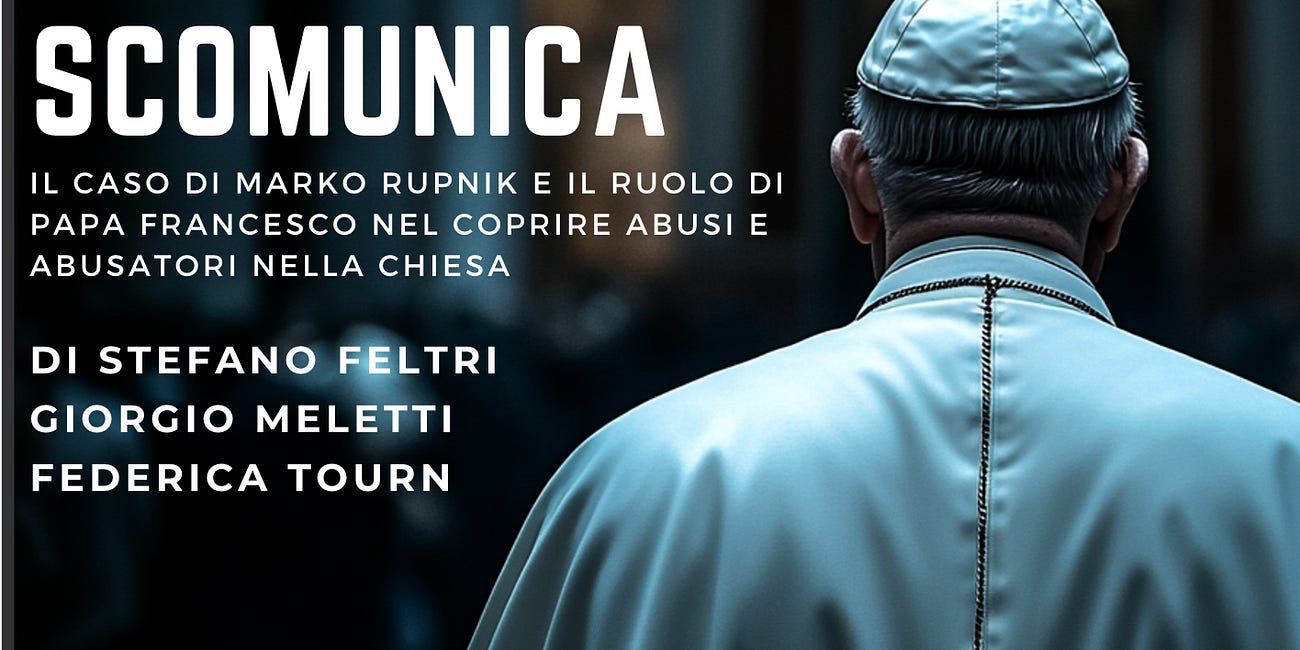
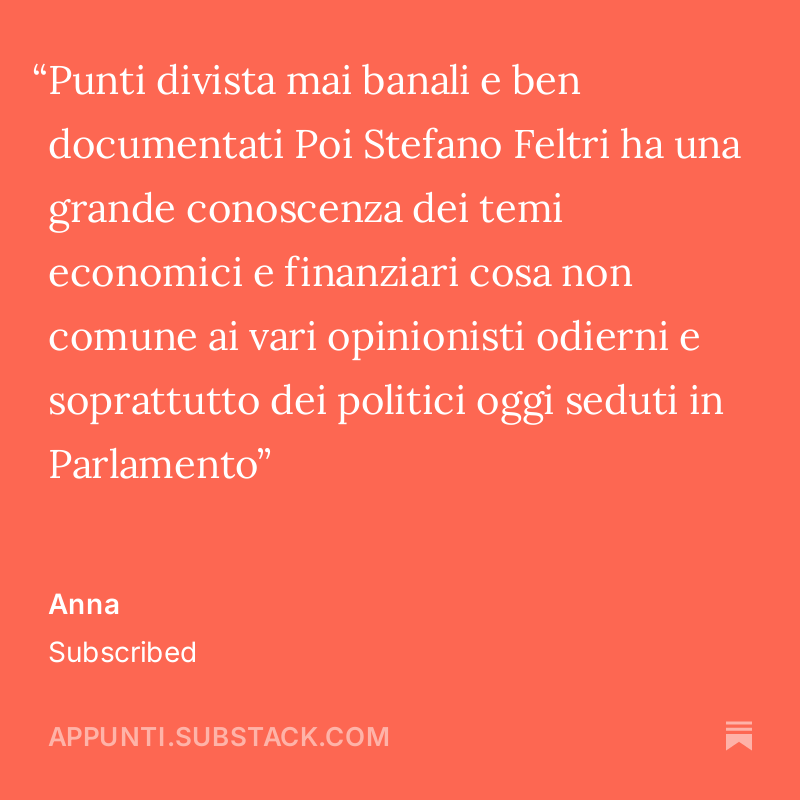








Trump non è un politico convenzionale, ma un negoziatore d’affari, conosce molto bene le dinamiche della trattativa aggressiva e le sfrutta a proprio favore. Quella recentissima dell'aumento dei dazi è una tipica tattica negoziale: chiedere il massimo possibile per poi ottenere comunque un risultato favorevole, anche se si "cede" qualcosa. L'azione di Trump rientra perfettamente nelle strategie descritte ne L'Arte della Guerra di Sun Tzu, in particolare nel principio del "creare pressione per ottenere vantaggi negoziali".
Sun Tzu insegna che l’illusione della forza può essere usata come strumento per condizionare l'avversario e spingerlo a negoziare da una posizione di svantaggio. Trump annuncia misure drastiche (che possono sembrare avventate o persino autodistruttive) , per costringere le altre nazioni a venire a patti, psicologicamente predisposte a dover “evitare il peggio”.
A quel punto, qualsiasi concessione fatta da Trump sembra un compromesso (la sospensione temporanea di alcune misure) mentre in realtà lui sta ottenendo quello che voleva sin dall’inizio.
Ma la vera questione è: ma Trump l'avrà letto "L'arte della Guerra" di Sun Tzu?
Scusate la domanda stupida, ma dovremmo forse chiederci se abbiamo ancora bisogno di un'USA come questa. La vecchia USA unione federale non esiste più, non so da quando. Sono 50 stati diversi e in competizione tra loro. Non sono certo un faro di Democrazia, come qualcuno continua a dire. Alcuni stati hanno leggi che a noi fanno rabbrividire, che si basano su presupposti che noi abbiamo superato dal 1860. La nostra elaborazione teorica di democrazia non sono riusciti a smontarla nemmeno i neofascisti al governo. La nostra applicazione del welfare è oggetto di studio.