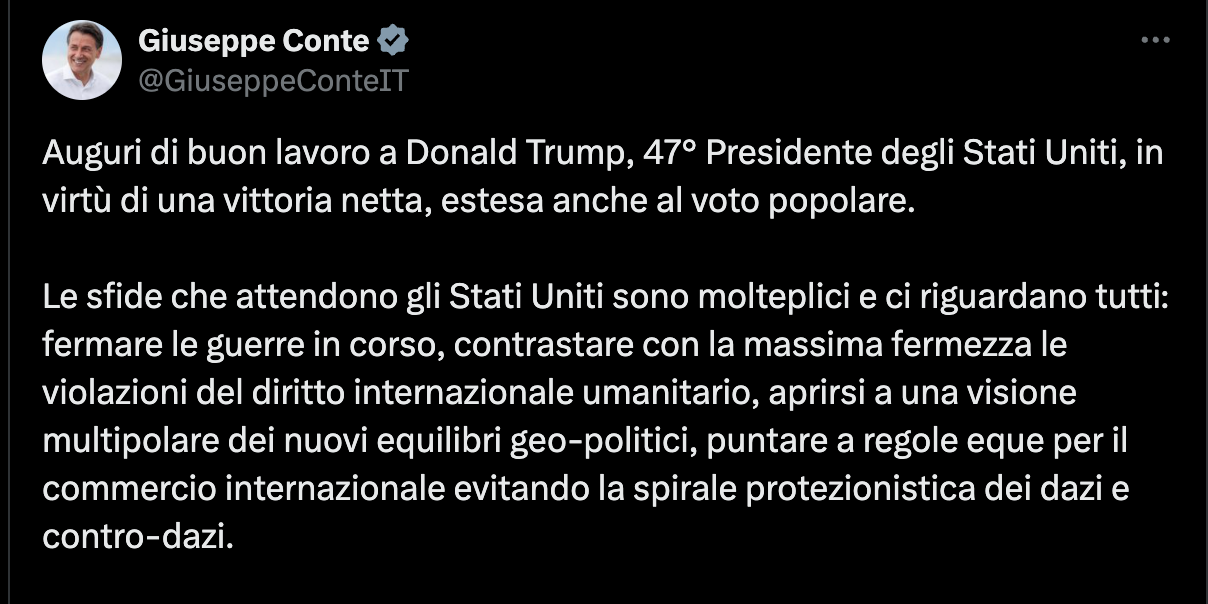USA e Italia, vi ricordate il primo mandato di Trump?
Tra 2017 e 2020 molte delle scelte di politica estera di Trump, rispetto a questioni di interesse immediato per l’Italia, hanno fatto più danni che altro. Ma pochi in Italia sembrano ricordarselo
Per gli Stati Uniti, restiamo certamente un alleato ma non siamo considerati così fondamentali. Nell’ultimo periodo si è notata una certa fatica transatlantica italiana
Dario Cristiani
La serie su Elon Musk
Dario Cristiani è Senior Resident Fellow del German Marshall Fund of the United States (GMF) e Visiting Senior Researcher dell’Institute for Middle Eastern Studies, King’s College, University of London.
Tanti, in Italia, sostengono che la netta vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane farà bene all’interesse nazionale italiano. Guardando indietro, però, molte delle scelte di politica estera di Trump, rispetto a questioni di interesse immediato per l’Italia, hanno fatto più danni che altro. È sorprendente come in Italia in pochi lo ricordino.
Ciò non significa che un’amministrazione Democratica sarebbe stata automaticamente migliore, come ciò non significa anche che la nuova amministrazione Repubblicana sarà necessariamente problematica: qui a Washington D.C. più di una persona è pronta a scommettere che Trump smusserà alcuni angoli del suo approccio internazionale.
La pace attraverso la forza
Ci sono in effetti svariati modi di declinare l’adagio reaganiano del “peace through strength" - proiettare forza, rafforzandosi militarmente, obbligando gli avversari a più miti consigli - che molti sostenitori di Trump avevano recuperato per l’occasione. Per esempio, le scelte di Marco Rubio e Mike Waltz rispettivamente come Segretario di Stato e Consigliere per la Sicurezza Nazionale, potrebbero non essere così devastanti per l’Europa, e quindi per noi.
Certo, poi bisognerà sempre vedere quando durano in quei ruoli. Trump ha abituato tutti – amici, nemici e neutrali – a sorprese su tutto lo spettro e licenziamenti repentini; quindi, non si può speculare troppo sul futuro, soprattutto quello non troppo immediato.
Da un punto di vista generale, in fin dei conti, per gli Stati Uniti, restiamo certamente un alleato ma non siamo considerati così fondamentali.
Nell’ultimo periodo si è notata una certa fatica transatlantica italiana. Le frequenti esclusioni da quello che in teoria sarebbe il Quint/Pent, il gruppo informale sull’Ucraina formato da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia - ma sempre più in realtà Quad transatlantico con Roma non sempre coinvolta – ne sono testimonianza.
Certo, molte questioni - una certa mancanza di fiducia americana rispetto alla nostra capacità di essere impermeabili alla pressione russa; le tante, troppe, incertezze sulla Cina; la ritrosia a investire soldi seri sulla difesa, e non per personale (pensioni e stipendi dei militari) o per il rinnovo ed ampliamento, come recentemente annunciato, di Strade Sicure, la missione che usa i militari con mansioni di polizia sul territorio italiano; l’egoismo su Haiti e altre situazioni ci fanno ricevere critiche (spesso bipartisan) a D.C.
Certo, non siamo ai livelli della mancata telefonata dell’allora Segretario di Stato Mike Pompeo all’allora ministro degli Esteri del governo giallo-rosso Luigi Di Maio, molto prima della conversione di quest’ultimo sulla via di Washington, dopo l’uccisione del comandante iraniano Qassem Suleimani il 3 gennaio 2020 (fu il segretario alla Difesa Mark Esper che chiamò l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini, all’epoca considerato il pilastro atlantista del governo Conte II, ma solo alcuni giorni dopo).
All’epoca, le posizioni di Di Maio su Cina, con l’onta del Memorandum che l’Italia firmò con la Cina per diventare parte della One Belt One Road Initiative (la Nuova via della Seta) ancora fresca nel marzo del 2019, Hong Kong e altri dossier avevano reso le relazioni un po’ complicate. Ma oggi non siamo neanche in una fase di totale armonia, nonostante l’atlantismo mostrato in questi anni dalla premier Giorgia Meloni.
Alcuni dei problemi elencati in precedenza andranno via con la nuova amministrazione, altri rimarranno, nuovi arriveranno. Ma, guardando indietro, ai primi quattro anni di Trump, molte delle scelte del presidente-rieletto sono state estremamente problematiche per l’Italia. La mancanza di memoria di tanti, in questo senso, è veramente sorprendente.
I danni del Trump 1 in Libia
Partiamo dalla Libia: senza l’avallo trumpiano tramite telefonata dell’azione militare del generale Khalifa Haftar nell’aprile 2019, tale iniziativa si sarebbe fermata e quanto meno sarebbe stata immediatamente contenuta.
All’epoca, le Nazioni Unite stavano cercando di promuovere un nuovo capitolo del dialogo nazionale tra i due governi libici (quello di Tripoli e quello di Beida/Tobruk), con una conferenza che si doveva tenere a Ghadames alla fine dell’aprile 2019.
Ma Haftar, andando anche contro gli interessi di alcuni dei suoi protettori esterni, lanciò questa azione a sorpresa che, nelle sue intenzioni doveva durare pochi giorni, e che gli avrebbe garantito il controllo su tutta la Libia.
Il supporto trumpiano, con la Casa Bianca che fino ad allora era stato molto poco interessato alla Libia, rafforzò l’azione di Haftar, nonostante altri pezzi del mosaico istituzionale americano, come ad esempio il Pentagono, continuassero a sostenere il governo legittimo di Tripoli.
Come risultato di questa guerra, però, l’Italia – che soffre quando deve muoversi in contesti militarizzati – perse l’influenza che aveva sul Governo dell’Accordo Nazionale e sul premier libico Fayez al-Sarraj.
Quest’ultimo era riuscito ad operare da Tripoli grazie all’azione italiana: ricordate il via vai di capi delle milizie di Tripoli a Roma tra il 2016 e il 2017? Trattavamo con le milizie? Ebbene si, in Libia si tratta(va) con le milizie.
In quegli anni l’Italia si fece promotrice di un approccio localista alla realtà libica: si trattava coi sindaci delle città del Fezzan sui migranti, si facevano accordi - alcuni anche discutibili - con i gruppi che controllavano le citta’ dalle quali partivano i migranti, e si cercava di convincere i capi delle milizie di quello che uno dei principali esperti europei di Libia, Wolfram Lacher, aveva definito come “il cartello di Tripoli.”
Le responsabilità di Obama
Il ruolo italiano in Libia si è ridimensionato in maniera epocale a causa di questa azione militare. Certo, la risposta del trumpiano italico di ferro potrebbe essere: e Barack Obama e il 2011? Per molti italiani, l’influenza italiana era scemata gia’ con l’intervento NATO del 2011.
Nonostante il famoso – o famigerato, a seconda delle visioni – “Leading from Behind” obamiano inaugurato con il riluttante supporto americano alla NATO in Libia nel 2011, in cui in sostanza gli americani supportavano la coalizione ma senza un ruolo preponderante dal punto di vista politico, a differenze di ciò che fecero in Afghanistan e in Iraq, pensare che quello sia il vero inizio della crisi libica – e dei problemi italiani in Libia – è eccessivo.
Nonostante qualche episodio di violenza, nel 2012 si tennero elezioni relativamente tranquille, il cui risultato fu accettato da tutti, e la produzione petrolifera era tornata a livelli simili a quelli pre-rivoluzionari già agli inizi di quell’anno.
L’inizio del caos libico che ha portato alla guerra del 2019 ha un’altra data, invece: il 5 maggio 2013, quando un'ampia maggioranza del parlamento provvisorio su pressione di molte delle milizie più radicali di Tripoli approvò la legge sull'isolamento politico.
Senza questa decisione, non ci sarebbe stato alcun Haftar, che sarebbe rimasto un ex militare - con la sua piccola milizia e con la doppia cittadinanza - con l’ambizione frustrata di non essere il nuovo Ahmed Chalabi (l’iracheno per decenni in esilio negli Stati Uniti che doveva guidare l’Iraq dopo Saddam nelle intenzioni degli americani) - e non sarebbe diventato il principale proxy russo/emiratino/egiziano in Libia. Senza Haftar, e con un approccio diverso di Trump, non ci sarebbe stata la guerra nel 2019, un’apocalisse per gli interessi italiani in Libia.
Reazione a catena
La Turchia, come risultato dell’azione militare di Haftar, ha preso il sopravvento nella Libia occidentale, a nostre spese: con un intervento militare legale ai sensi del diritto internazionale (supporto militare richiesto da un governo legittimo contro un aggressore, supporto che inizialmente fu chiesto proprio all’Italia), con la fine dell’isolamento turco nel Mediterraneo orientale, e con un’egemonia turca in divenire in quasi tutti i settori d’interesse nella Libia occidentale (basta seguire la storia del nuovo aeroporto internazionale e di chi ci deve investire).
La Russia, invece, è diventata l’attore di riferimento per i gruppi nella Libia orientale, territorio divenuto la piattaforma logistica principale in supporto alla presenza russa nel Sahel. Altro disastro: non solo per l’Italia, ma più in generale per l’Europa.
Lievemente più ad occidente, ma restando nel Maghreb: L’Italia, negli ultimi anni, ha costruito un ruolo interessante da ponte europeo con gli algerini.
Ma c’è un problema, di sostenibilità: prima o poi questo ruolo verrà messo alla prova dalla questione del Sahara Occidentale.
Il riconoscimento americano della sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale avvenuta sotto Trump – nell’ambito più ampio della questione degli accordi di Abramo – ha cambiato le dinamiche diplomatiche di questa questione a livello globale, modificandone in maniera sostanziale il paradigma centrale, chiaramente in senso pro-marocchino.
La disputa sul Sahara Occidentale contrappone dal 1975 il Marocco, che ha annesso l'ex territorio controllato dalla Spagna, al Fronte Polisario, che cerca l'indipendenza del territorio con il sostegno dell'Algeria.
Nei decenni precedenti, tutte le amministrazioni statunitensi avevano mantenuto un approccio di neutralità, ribadendo che la questione doveva essere discussa nel quadro delle Nazioni Unite. In genere, le amministrazioni repubblicane si sono dimostrate più sensibili ai desiderata di Rabat, ma mai fino al punto tale da modificare l’approccio in maniera sostanziale come fece Trump.
Certo, Biden non ha fatto nulla per modificare questo passaggio, nonostante molti nella sua amministrazione non fossero convintissimi, ma sarebbe stato difficile cambiare una decisione di tale portata senza bruciare un alleato come Rabat.
L’Italia, che al momento riesce a stare in equilibrio su questa questione semplicemente evadendola quando possibile, ad un certo punto dovrà prendere una posizione. Francia e Spagna già hanno pagato pegno, infuriando gli algerini. Restare in equilibrio sarebbe più semplice se il riconoscimento americano non fosse mai avvenuto, e fu Trump il responsabile di questo passaggio epocale.
Nonostante lo sbandierato pivot verso l’Asia-Pacifico, annunciato ai tempi dell’amministrazione Obama e che avrebbe dovuto portare gli Stati Uniti a privilegiare le questioni di questo quadrante rispetto a problemi europei e mediorientali ma che, in molti passaggi, è rimasto più nelle intenzioni, gli americani – anche se sono chiaramente meno interessati al Grande Medio Oriente – continuano ad influenzarne le dinamiche, anche senza volerlo apertamente. Esempio ormai classico nella letteratura politologica sulla regione: la presidenza Trump e le dinamiche nel Golfo Persico.
L’arrivo di Trump e il suo supporto alla coppia saudita-emiratina fece da detonatore alla crisi culminata con il blocco e l’isolamento del Qatar nel 2017, visto che i due paesi, insieme all’Egitto, pensavano che il supporto americano avrebbe garantito loro una certa libertà di manovra per spingere Doha a piu’ miti consigli.
Trump, in quei giorni, mise anche un ulteriore carico accusando il Qatar di “essere sponsor del terrorismo.” Questo nonostante il Qatar fosse – come lo è tuttora – un alleato fondamentale americano, sia come negoziatore con attori complicati sia come piattaforma logistica per la proiezione militare americana nel Golfo Persico.
Certo, le tensioni esistevano da anni, da quando il Qatar aveva iniziato ad avere una politica estera più assertiva, supportando le diverse declinazioni della Fratellanza Musulmana dopo le Primavere Arabe, e Arabia Saudita e ed Emirati Arabi Uniti si erano posti a capo del cosiddetto blocco “contro-rivoluzionario”, ma il salto di qualità ci fu con l’arrivo di Trump.
L’amministrazione trumpiana si rese poi conto del problema, cercando di contenerlo, ma fu solo con l’avvento di Biden che la situazione cambiò. In primis, tale passaggio forzò l’Arabia Saudita a rivedere le sue posizioni. Biden arrivò alla Casa Bianca con l’intenzione di far pagare ai sauditi l’uccisione di Jamal Khashoggi, minacciando il paese di renderlo uno “Stato Paria”.
Moḥammad bin Salmān, attuale primo ministro del paese (dal 2022), figlio dell'attuale re Salman, primo in linea di successione al trono dell'Arabia Saudita, all’epoca vice primo ministro e ministro della Difesa, uno degli architetti della pressione contro Doha, si mosse da subito per gestire questo passaggio, ed in effetti le relazioni tra sauditi e americani non hanno subito scossoni enormi negli ultimi quattro anni. Tale passaggio spinse anche i riluttanti emiratini a chiudere la partita contro Doha.
La sconfitta di Trump nel 2020 e l’arrivo dell’amministrazione Biden nel 2021 fece quindi da apripista alla fine del blocco contro il Qatar, sancito durante il 41esimo Summit del Consiglio di Cooperazione del Golfo, tenutosi il 5 gennaio 2021 nella città saudita di al-Ula. Certo, tale blocco si era mostrato inutile e il Qatar era riuscito a gestirlo, ma le tempistiche su lancio e ritiro del blocco dicono tanto su quali siano stati le variabili che portarono Riyadh e Abu Dhabi prima a promuoverlo e poi ritirarlo.
Più in generale, nel 2021, iniziò quello che molti osservatori hanno poi definito il Grande Reset mediorientale, che ha coinvolto anche altri attori regionali come Turchia ed Egitto, in larga parte nato come risposta all’arrivo di un’amministrazione democratica a D.C.
Cosa serve all’Italia in Medio Oriente
Perché questa polarizzazione rappresentava un problema per l’Italia? L’Italia ha dato storicamente il meglio di sé, in Medio Oriente, quando ha potuto evitare di parteggiare apertamente per qualche paese rispetto ad altri.
La polarizzazione nella regione danneggia Roma, quasi in automatico. Infatti, in quegli anni, la nostra posizione nel Golfo peggiorò, e con essa i problemi legati a quei quadranti dove i paesi del Golfo contavano e contano (come la sempre presente Libia).
La leggerezza dimaiana con il pasticcio delle licenze nel gennaio 2021 diede il colpo di grazia. Dopo una sospensione di 18 mesi dell'export di missili e bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia decise di fermare le forniture autorizzate negli ultimi anni di ordigni che venivano utilizzati nella guerra dello Yemen, annullando retroattivamente le licenze che erano state autorizzate.
Di Maio dichiarò che ciò era “un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese. Il rispetto dei diritti umani è per noi inderogabile.” Tale passaggio portò i rapporti con entrambi i paesi, in particolare con gli emiratini, ai minimi storici.
Ma i problemi di contesto erano nati nei quattro anni precedenti ed erano dovuti a questa polarizzazione anti-Qatar che ci aveva danneggiato e che non eravamo riusciti a gestire.
Non è detto che questi problemi si ripetano, e sta all’Italia agire sapientemente per guadagnare il più possibile dalle scelte della prossima amministrazione repubblicana. Ma i cantori italiani della “pax trumpiana” globale – anche quella da contestualizzare in molti aspetti - questi passaggi se li ricordano?
Le opinioni espresse nell’articolo sono solo dell’autore e non del GMF e il KCL
Video: Make America Great Again - La lezione di Manlio Graziano
Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni
Iscriviti a Appunti - di Stefano Feltri per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.