Se fosse solo un film
San Damiano ci costringe a discutere di povertà, di esclusione, degli ultimi. Ma rafforza l’illusione rassicurante di una separazione netta tra “noi” e “loro”
In San Damiano scompare la città non come contesto strutturale (Damiano vive in una torre…), ma come ecosistema relazionale. Il fenomeno dei senza dimora è un “prodotto” metropolitano per eccellenza e non affrontando la relazione tossica che la città ha con i cittadini marginalizzati significa non raccontarli, almeno non in senso documentaristico
Girolamo Grammatico
Con il suo saggio, Christian Raimo ha aperto un interessante dibattito: il docufilm San Damiano, che racconta gli homeless della stazione Termini con una crudezza di stile e di intento che nulla vuole edulcorare, ci costringe a ragionare su disuguaglianza, degrado, e responsabilità verso gli ultimi? O, al contrario, genera una facile empatia che nasconde le responsabilità strutturali, politiche, sociali, dietro alla gestione del disagio, che non è solo povertà? Insomma, San Damiano è una “operazione verità” o un safari del degrado?
Abbiamo chiesto l’opinione di Girolamo Grammatico, che per molti anni ha lavorato in un ostello alla stazione Termini, proprio a occuparsi delle persone che vediamo spesso buttate in strada durante il giorno, tra alcol, problemi psichici e altri drammi.
Da quella esperienza ha tratto un romanzo potente e disturbante, che è uscito l’anno scorso per Einaudi: I sopravviventi.
Quando l’ho letto, mi ha così impressionato che mi sono ripromesso di parlarne appena potevo, ma parlare di povertà e disagio è difficile, specie per chi - come me - può farlo solo da osservatore, a distanza, senza confrontarsi davvero con questi temi, con quelle persone.
Alla fine, come credo quasi tutti quelli che leggono queste righe, io sono uno di quelli che cerca di evitare i tanti Damiano di Termini, o che teme di esserne infastidito, che vorrebbe soltanto non vederli.
Il dibattito innescato da Christian Raimo su San Damiano è l’occasione giusta per coinvolgere finalmente Girolamo Grammatico. (Stefano Feltri)
Questo pezzo di Girolamo Grammatico è disponibile senza paywall: vogliamo che il suo contributo possa circolare liberamente, stimolando una riflessione collettiva e un dibattito aperto. Se ritieni che Appunti sia uno spazio importante e vuoi aiutarci a mantenerlo accessibile, prendi in considerazione un abbonamento a pagamento o regala l’accesso a qualcuno che apprezzerà il nostro lavoro.
San Damiano e i sopravviventi
di Girolamo Grammatico
Ho visto San Damiano il 13 maggio grazie a un mio amico che è stato invitato direttamente da uno dei due registi, Alejandro Cifuentes.
Questo mio amico, di cui non farò il nome per non trascinarlo in una riflessione pubblica alla quale non ha chiesto di partecipare, ha pensato bene di coinvolgermi perché ho lavorato per quasi un ventennio con le persone senza dimora, perché ho studiato il fenomeno, perché ho letto tutto ciò che potevo leggere su quanto riguarda l’homelessness e perché ho scritto un libro su alcune contraddizioni legate al mondo del welfare.
Così, con i due accrediti, ci siamo diretti al cinema Troisi. Aveva piovuto da poco e molte pozzanghere ostentavano la loro superiorità rispetto allo scooter del mio amico. Ricordo di essere arrivato con una scarpa zuppa d’acqua e di sperare, imbarazzato, che nessuno se ne accorgesse.
La prima cosa che mi ha colpito, una volta arrivati, è stata la grande affluenza di giovani. Per giovani intendo gli under 35, visto che io sono un over 45. E ho pensato immediatamente, in una sorta di flashback molto cinematografico, a tutte le fatiche fatte negli anni zero per avvicinare quello stesso target alla conoscenza del problema.
Per anni abbiamo organizzato (con questo “noi” intendo: operatori sociali, volontari, attivisti, associazioni, enti, ecc), ogni 17 ottobre, Giornata Mondiale per l’eliminazione delle miserie, un’esperienza di condivisione con le persone senza dimora: dormire una notte in strada con loro. Difficile, ma niente di impossibile.
L’obiettivo era: condividere, informare e sensibilizzare attraverso un’esperienza simbolica, ma reale e autentica. Eppure ogni anno, nonostante gli sforzi di tutti gli attori in gioco, eravamo sempre più pochi e sempre più anziani.
Invece San Damiano era riuscito, senza ancora dire o fare nulla, ad avvicinare tutti quei giovani e quelle giovani in un unico luogo, a farli e a farle sedere in rigoroso silenzio e far vivere loro un forte momento di riflessione su una realtà quotidiana e invisibilizzata.
Ecco, credo che questo sia già un grande merito e può diventare ancora più grande se la riflessione diventa, per citare Bruno Mastroianni, una disputa felice. Per disputa felice s’intende quel momento di confronto che permette alle parti di mantenere il proprio punto di vista e contestualmente una relazione tra le parti stesse.
Oltre l’arte
Perché se San Damiano fosse un film, secondo me sarebbe un gran bel film. Io che non sono un esperto cinefilo ne potrei apprezzare la fotografia, il perturbante, la rottura di alcuni postulati etici a favore di una estetizzazione esplosiva, la ricerca costante del contagio emotivo tra personaggi e pubblico.
Se San Damiano fosse un film, vedere gli attori impersonare se stessi mi porterebbe a collocarlo in quella categoria dei cult dal genere atipico.
Se fosse un film sarebbe la storia di Damiano, aspirante rapper con problemi psichiatrici che dall’ospedale polacco in cui viveva (o sopravviveva) si rifugia a Roma nella speranza di diventare un artista riconosciuto per finire a vivere nei pressi della stazione capitolina. Se fosse un film sarebbe un film su un gruppo di persone con dipendenze varie e problemi psichiatrici vari che si sostengono a vicenda (fallendo) e facendo la vita di strada. Se fosse un film sarebbe la storia d’amore, disfunzionale, tra Damiano e Lucia.
È arte, direbbe il mio amico (che di arte vive), può piacere o non piacere, ma l’arte combina le cose con schemi che rompono gli schemi.
Allo stesso tempo San Damiano è anche un documentario (la definizione corretta è quella di docufilm) che, per l’appunto, vorrebbe documentare una realtà: quella delle persone senza dimora. E, per ammissione degli stessi registi, tenta di farlo con autenticità impegnandosi a far sparire la telecamera a favore del realismo.
Ecco, secondo me, questa è la parte più problematica del docufilm. Perché se nelle intenzioni dei registi c’è la volontà di denuncia sociale rendendo visibile l’invisibile, l’impatto che poi ha il film, rispetto a queste intenzioni, non è abbastanza efficace.
Mi sono chiesto per giorni dove si annidasse la problematicità di quest’opera e se poi Giuseppe Rizzo e Christian Raimo l’hanno spiegato egregiamente, sento che manchi ancora qualcosa nella riflessione e mi piacerebbe aggiungere un contributo.
Ricapitolando: se quindi il film è una narrazione immaginaria, il documentario al contrario registra la realtà pur interpretandola, il docufilm parte da fatti veri, li drammatizza e li ricostruisce per creare un coinvolgimento diverso. In questo coinvolgimento ipnotico di San Damiano vedo un’occasione mancata.
I due registi hanno deciso di seguire il senza dimora Damiano con sguardo scevro da condizionamenti e quindi non hanno studiato e affrontato la letteratura sul disagio abitativo per fare in modo che fosse Damiano, con la sua vita, a raccontarsi.
Ma nel momento in cui la telecamera scompare, scompare la relazione e nel caso delle persone senza dimora uno dei parametri per affrontarne la complessità è proprio la questione relazionale.
Chi è la telecamera? Il regista? Sarebbe banale. La telecamera siamo noi? Possibile. La telecamera è la città. In San Damiano scompare la città non come contesto strutturale (Damiano vive in una torre…), ma come ecosistema relazionale.
Il fenomeno dei senza dimora è un “prodotto” metropolitano per eccellenza e non affrontando la relazione tossica che la città ha con i cittadini marginalizzati significa non raccontarli, almeno non in senso documentaristico.
La solitudine di Damiano è l’isolamento in cui lo costringe la società. L’invisibilità di Damiano è la cecità selettiva della metropoli. Damiano e company non sono poveri: sono impoveriti, che è diverso. Tutto ciò scompare e il senso di impotenza che ti lascia il film è frutto del viaggio dell’eroe che i regesti hanno costruito in fase di montaggio (pensate che il girato supera le cento ore nell’arco di un anno).
Mentre la telecamera sublima se stessa nella ricerca dell’autenticità aiuta lo spettatore a de-responsabilizzarsi nei confronti di un fenomeno che ci riguarda tutti e tutte. Damiano viene raccontato come vittima di una storia familiare tristissima, di una patologia psichiatrica invalidante, di un alcolismo distruttivo.
Il riscatto di Damiano attraverso il rap è un’altra illusione del film. Il sogno di Damiano è il sogno ingenuo del bambino, non l’aspirazione dell’artista e la scena che lo vede nel panico, tutto sudato tra una crisi d’astinenza da alcol e l’incapacità di esprimere i suoi pensieri attraverso il freestyle nello studio di registrazione degli amici dei registi commuove perché rappresenta la spettacolarizzazione del dolore a cui i social ci hanno abituato passivamente.
Eppure, alla fine, Damiano riesce a rappare un pezzo che, come dice il mio amico, “spacca” e, come direbbe sempre il mio amico, questo è anche il valore del film: dimostrare che alla fine Damiano ha un talento, che con le risorse giuste, può fare dei pezzi rap belli.
Pur riconoscendo che questa narrazione offre una possibilità di riscatto, non posso fare a meno di chiedermi: perché è sempre necessario dimostrare di avere una qualità, una virtù, un talento per essere riconosciuti e ascoltati?
Damiano non meriterebbe di essere aiutato, sostenuto, abbracciato e raccontato semplicemente in quanto persona, senza la necessità di dover dimostrare un valore aggiunto?
Il passaggio da Damiano incapace (nel senso letterale del termine) di fare rap a Damiano che registra un singolo di qualità diventa così un dispositivo narrativo che forse serve più a noi spettatori, bisognosi di redenzione e lieto fine, che a restituire un reale racconto delle persone senza dimora.
C’è un passo nel libro di Alessandro Sahebi, Questione di classe, che spiega involontariamente dove si colloca un prodotto come quello di San Damiano:
“Secondo il Creative Industries Policy and Evidence Centre, le persone provenienti da ambienti privilegiati hanno il doppio delle probabilità di essere impiegate nelle industrie creative rispetto a quelle provenienti da ambienti umili.”
Questo porta, sempre secondo Sahebi, a una situazione in cui “una nicchia di classe determina la narrazione della realtà”
Come dicevo prima, se le intenzioni del docufilm sono lodevoli, il loro impatto si inserisce nel già detto. Dare voce a chi non ha voce, grande slogan dell’associazionismo, è spesso un atto classista se non pensato a monte con studio matto e disperato, per citare il sommo poeta.
San Damiano acquista valore quando riesce ad accendere la miccia di una riflessione a catena. Può diventare davvero grande se spinge il pubblico a interrogarsi sul proprio ruolo rispetto a tutti i Damiano che popolano le stazioni.
La visione della cura
Se gli spettatori usciranno dalla sala chiedendosi chi altro ha raccontato queste storie, come, perché e come mai non ne hanno saputo nulla prima, allora l’impatto sarà realmente all’altezza delle intenzioni.
È per questo che credo San Damiano sia ancora più prezioso se affiancato ad altri prodotti culturali simili.
Penso al film Bassifondi di Trash Secco che fa l’operazione inversa: usa l’estetica letteraria per raccontare la vita di chi vive ai margini e ci riesce benissimo.
Oppure penso a Chav-Solidarietà coatta di D. Hunter, un memoir narrato in prima persona da chi la povertà l’ha vissuta, dove la storia individuale si intreccia con una riflessione politica e sociale potente: Hunter racconta non solo la sua lotta per la sopravvivenza, ma anche la stigmatizzazione e l’esclusione sistemica subite dai ceti popolari inglesi. Il testo è un esempio di scrittura dal basso, capace di illuminare la complessità della marginalità contemporanea.
Un altro esempio è Storia di mia vita di Janek Gorczyca, in cui la vicenda personale dell’autore, cresciuto tra Polonia e Italia e segnato da esperienze di povertà, dipendenze e carcere, si fa occasione per una riflessione più ampia sulle dinamiche sociali e culturali che intrappolano le vite ai margini.
Il racconto in presa diretta, privo di filtri, permette al lettore di entrare davvero nelle dinamiche dell’indigenza, ma anche di cogliere le trame di solidarietà, esclusione e riscatto che percorrono le biografie più fragili.
Credo che l’idea dell’arte fine a se stessa sia ormai superata: non tiene conto della responsabilità di chi racconta e rischia di renderci ostaggi non dell’arte, ma dei nostri stessi bias inconsapevoli.
I docufilm come San Damiano funzionano davvero quando il dilemma morale che mettono in scena riesce a generare nello spettatore domande nuove, capaci di trasformarsi in pensiero critico e in un atteggiamento proattivo verso la realtà.
Il valore aggiunto di queste opere non sta solo nel rappresentare il disagio, ma nell’attivare una riflessione che spinga chi guarda a interrogarsi sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità, al di là della semplice empatia o commozione.
Il mondo di San Damiano appare polarizzato in categorie che sembrano non comunicare tra loro: cittadini “normali” che attraversano la città senza consapevolezza; persone con disturbi psichiatrici abbandonate per strada; viaggiatori che passano dalla stazione e senza dimora che nelle sue vicinanze hanno trovato una precaria stabilità; donne vittime di violenza e uomini autori di violenza; anziani soli e giovani ai margini in cerca di un pasto decente.
Ci sono i volontari e gli assistiti, i ricchi e i poveri: compartimenti stagni che raramente si incontrano davvero, se non in modo funzionale e mai relazionale. Questa divisione netta, quasi archetipica, restituisce il senso di una città frammentata dove la vera distanza non è solo materiale, ma soprattutto sociale e umana.
Quello che manca, secondo me, è una rottura netta con le solite categorie della strada e del disagio: servirebbe una nuova visione, un nuovo modo di tenere la telecamera sempre accesa, capace di vedere più cose e più persone, non solo ciò che già sono state abbondantemente raccontate.
Prendendo in prestito le parole di Rosalynn Carter, occorre la "visione della cura". Carter divide il mondo in quattro grandi categorie, forse le più universali mai teorizzate: chi si prende cura di altri, chi lo ha fatto in passato, chi dovrà farlo in futuro, e chi avrà bisogno di essere curato.
Guardare San Damiano alla luce di questa prospettiva della cura riporterebbe la telecamera a essere uno strumento utile, capace di raccontare le persone senza dimora posizionandoci tutti in una dimensione nuova, più inclusiva e relazionale. Ci permetterebbe di avere un impatto nuovo.
Non chiedere troppo all’arte; lascia che sia libera, senza doverle attribuire obblighi di responsabilità sociale, ha sottolineato il mio amico.
Secondo lui, l’arte ha diritto di esistere anche senza una funzione sociale o un intento pedagogico: può semplicemente provocare, commuovere, disturbare, far riflettere o anche solo essere.
Fallo tu! Ha aggiunto, sorridendo, quasi a ricordarmi che ognuno si assume la sua parte di racconto e di cura.
Quel 13 maggio, il mio amico e io abbiamo parlato a lungo, senza trovare un punto d’accordo, ma sentendoci entrambi arricchiti dalle nostre riflessioni.
In una pausa di silenzio, ho abbassato lo sguardo e ho visto che la mia scarpa non era più bagnata.
Ho pensato al mio imbarazzo iniziale, a quell’ansia per il giudizio altrui che spesso ci accompagna e mi sono detto che è così che viviamo: con una telecamera sociale che ostenta il suo sguardo colpevolizzante su di noi.
Se questo pezzo di è piaciuto, considera di regalare un abbonamento ad Appunti a qualcuno a cui tieni
Da leggere su Appunti
La battaglia per le teste degli studenti
La storia è una grande lezione di metodo: dobbiamo sempre chiederci come sappiamo quello che sappiamo







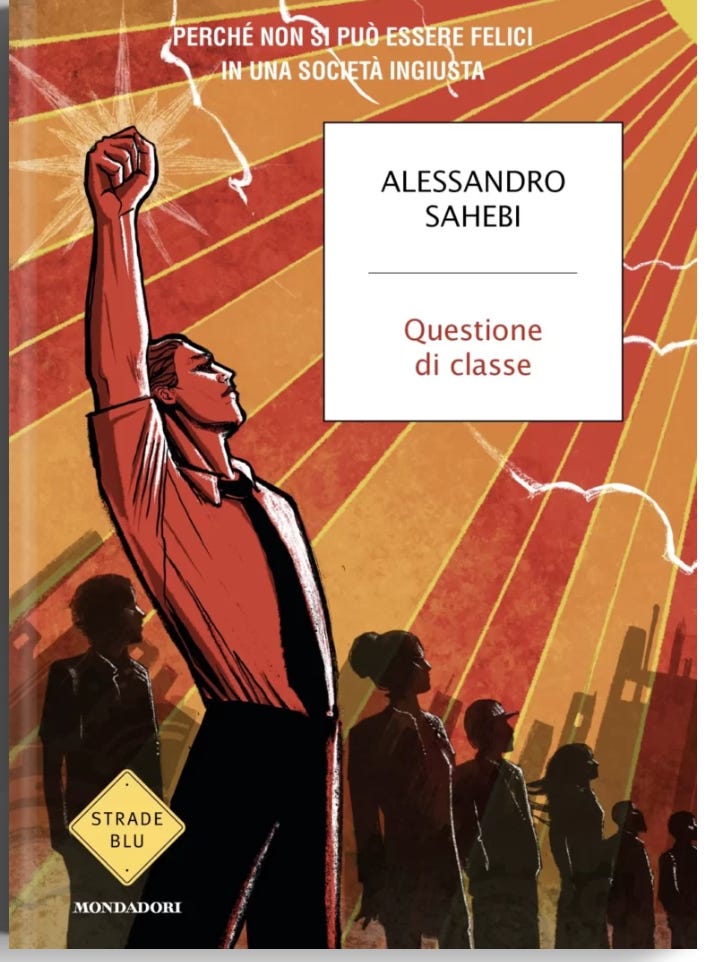

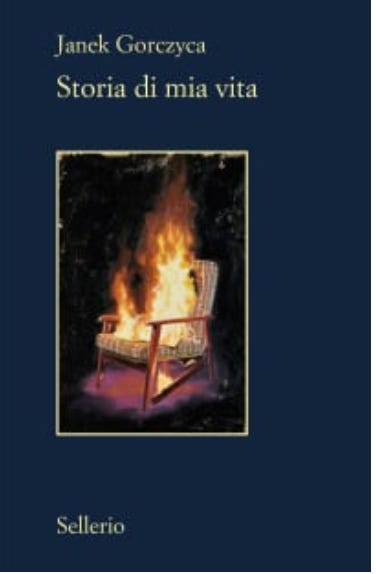


Commento fantastico, condivido in pieno!!
Mancherebbe tuttavia un punto all'analisi: anche un film è un prodotto sociale e non può esistere e prosperare senza un pubblico. Ma se il messaggio del film non è compreso da tutto il pubblico, il film non potrà prosperare....
Vous qui passez sans me voir
Sans même me dire bonsoir
Donnez-moi un peu d'espoir ce soir