La scuola degli anni Venti
Quello che è successo in Italia tra 1922 e 1925 ricorda molto quanto sta capitando ora, nel 2025. Da Mussolini-Gentile a Meloni-Valditara. Un saggio di Christian Raimo
La scuola di Gentile non possiamo ridurla a una scuola fascista, la scuola di Valditara non possiamo ridurla a una scuola postfascista, nonostante entrambi siano ministri di governi che dichiarano la loro ideologia senza infingimenti: stiamo parlando invece di una ideologia liberal-nazionalista che ha continuità che sono profonde e di lunghissima durata
Christian Raimo
Le analogie tra quello che è accaduto alla scuola italiana tra il 1922 e il 1925 e quello che sta accadendo alla scuola italiana esattamente cento anni dopo sono tante e tali che viene la tentazione di fare un paragone tra il governo Meloni-Valditara e quello Mussolini-Gentile che può portarci a due esiti interessanti: riflettere sui rapporti tra il fascismo e il liberalismo di un secolo fa, e riflettere sui rapporti tra il postfascismo e liberalismo e neoliberismo di questi tempi.
La storiografia sulla scuola fascista rivela vari nodi intrecciati: un po’ perché tutta la storia della scuola è sempre complicata dalla difficoltà di lavorare sulle fonti primarie (quello che si fa a lezione, anche i quaderni, i disegni, i compiti a casa…) ed è in genere meno considerata dagli storici quasi fosse una storia ancillare; un po’ perché la riflessione sulla scuola fascista si concentra soprattutto sull’aggettivo fascista trascinando con sé tutte le questioni storiografiche del fascismo.
La scuola fascista: tra forma e sostanza
I due libri monografici di riferimento sono uno del 1981 e uno del 1994. Il primo si intitola La scuola italiana durante il fascismo e l’ha scritto Michel Ostenc, il secondo s’intitola Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime 1922-1943 e l’ha scritto JürgenCharnitzky.
Volendo essere piuttosto grossolani, nel primo passa l’idea che il progetto di fascistizzazione attraverso l’educazione sia stato piuttosto fallimentare e che la scuola sia rimasta meno trasfigurata dall’infezione totalitaria del fascismo; nel secondo si ricostruisce meticolosamente la politica scolastica del regime e si cerca invece di vedere come sia problematico mostrare e dimostrare la penetrazione dell’ideologia fascista nella scuola, proprio a causa delle difficoltà – soprattutto nelle fasi di affermazione del fascismo – di riconoscere questa penetrazione avvenuta in modo pulviscolare e viscoso.
Continuando a essere schematici, possiamo individuare quattro fasi della scuola fascista che un po’ corrispondono anche a una periodizzazione del fascismo in sé.
La prima è quella legata alla riforma Gentile, alla sua lunga elaborazione avvenuta anche nell’Italia prefascista e ai suoi immediati effetti; la seconda ha luogo con la trasformazione del regime e con l’ambizione di fascistizzare le istituzioni (la seconda parte degli anni venti); la terza è a partire dal 1929-30 dopo i Patti lateranensi, con l’introduzione del libro di testo unico, l’adesione forzata dei docenti al fascismo; la quarta coincide con il progetto imperialistico del fascismo e quindi con una pedagogia di regime che va a supportare questo progetto.
Potremmo definire la prima fase insieme liberale e fascista o pre-fascista, le altre tre fasciste tout-court.
Il momento che ci interessa analizzare è proprio il primo.
Il 1925 è l’anno terminus a quo in cui il fascismo ostenta la sua involuzione illiberale, l’anno della rivendicazione da parte di Mussolini del delitto Matteotti, scelta che comincia a provocare per esempio la presa di distanza/allontanamento di Giuseppe Lombardo Radice, il pedagogista che più di tutti collabora con Giovanni Gentile per la sua riforma.
La scuola fascista quanto è stata fascista? Il progetto gentiliano quanto è fascista? Non è un caso, forse, che venga proprio dal figlio di Giuseppe Lombardo Radice, il matematico e pedagogista Lucio Lombardo Radice, un’interpretazione del rapporto tra fascismo e scuola come anfibolica.
In un suo saggio intitolato Le due scuole, messo a postfazione di …voi siete la primavera d’Italia. ... L’ideologia fascista nel mondo della scuola 1925–1943 (un volume sulla scuola fascista pubblicato nel 1982) Lucio Lombardo Radice parla di «duplice anima della scuola», indicando una convivenza quasi ontologica tra elementi antidemocratici-totalitarie elementi democratici-antitotalitari, pensando che i primi possano essere soprattutto relegati a aspetti secondari, superficiali, o sovrastrutturali.
La diarchia era molto evidente. Da una parte la scuola – preside, professori (compreso quello di religione) – con le sue lezioni, dall’altra l’Opera nazionale balilla, colle sue gerarchie e le sue adunate.
I ragazzi avevano una doppia vita: erano da un lato alunni, dall’altro balilla, giovani italiane, avanguardisti. Due personalità, diverse anche nel vestire. Due culture. L’una umanistica, in questo o quel senso, ma comunque umanistica (per questo non abbiamo collocato in un angolo a parte l’insegnante di religione, allora direi sempre sacerdote, portatore in generale di un umanesimo cristiano), l’altra antiumanistica, sciovinistica, carica di boria della nazione, di impero e sopraffazione.
Due collettività separate, e rette da leggi e idealità diverse.
La classe, nella quale la disciplina era impegno di studio intelligente, di comprensione, spesso anche di creatività, di dialogo, di rispetto per il diverso. Il plotone, dove disciplina significava “credere, obbedire, combattere”; obbedire senza discutere agli ordini (del Duce in linea di principio, del capo-manipolo suo rappresentante in terra in linea di fatto).
Quest’idea di uno strabismo pedagogico e di una convivenza non solo possibile ma strutturale tra forme democratiche e forme antidemocratiche non convince diversi storici, prima fra tutte Monica Galfré, che è tornata diverse volte proprio sulle implicazioni storiografiche oltre che politiche di questa ipotesi di duplicità: sbrigarsela con la duplicità come fa Lucio Lombardo Radice, o parlare di fallimento come fa Ostenc, per Galfré non ci fa né riconoscere né studiare fino in fondo se e come è avvenuto il processo di fascistizzazione della scuola e della società in generale.
Nel 2010 Galfrè scrive un saggio che pone in maniera dichiarata questo interrogativo, Consenso e coercizione nella scuola fascista, che inizia così:
Appare ancora profondamente radicata, nella ristretta cerchia degli specialisti e più in generale nella memoria collettiva, un’immagine consolatoria e assolutoria della scuola del ventennio fascista: quella cioè di un mondo pienamente asservito al regime, ma solo o quasi solo negli aspetti esteriori.
Fin dai suoi esordi la storiografia è sembrata arenarsi su un dilemma di per sé più che legittimo che però, invece di stimolare la ricerca, ha finito per ipotecarne e inibirne gli sviluppi: la scuola è stata fascista solo nella forma o anche nella sostanza?
Prima del regime
Nel 2017, nella sua storia della scuola italiana Tutti a scuola!, la questione si allarga anche alla storiografia degli anni successivi al fascismi, in una sorta di storia degli effetti della riforma Gentile.
Se studiamo la scuola fascista con questa cautela, ci fa tirare quasi un sospiro di sollievo rispetto agli spettri del fascismo che oggi vediamo all’orizzonte, ma può essere un effetto distorsivo.
Leggere la scuola come “il tallone d’Achille” del progetto di fascistizzazione della società, e come l’esempio più preciso di quella prospettiva storiografica che definisce il fascismo come “totalitarismo imperfetto”, non ci fa mettere a fuoco come i totalitarismi crescono e si radicano anche quando non sono perfetti.
Per questo qui stiamo occupando di qualcosa di più preciso invece che dell’intero ventennio. Per rispondere alla questione fascismo/democrazia nella scuola occorre concentrarci innanzitutto sulla fase 1922-1925, la riforma Gentile e dintorni.
Prendiamo per esempio i programmi per le scuole elementari del 1923, redatti proprio da Giuseppe Lombardo Radice come addentellato della riforma Gentile; questa è la premessa che scrive Giuseppe Lombardo Radice:
Si addita al maestro il risultato che lo Stato si attende dal suo lavoro, in ciascun anno di scuola, pur lasciandolo libero di usare, per ottenerlo, i mezzi opportuni.
I quali, per molte ragioni, sono sempre varii e mutevoli in rapporto alla situazione concreta nella quale il maestro si trova, in un dato ambiente scolastico, ed in rapporto con la personale cultura del maestro e con la particolare tempra che egli sarà riuscito a dare, attraverso una vigile esperienza, al proprio spirito di educatore.
Non stiamo parlando di autonomia scolastica, ma sicuramente sembra ci si richiami a un’idea di libertà di insegnamento che non era inclusa né specificamente né implicitamente nello Statuto albertino, dove si parlava genericamente di libertà individuali, ma che sarà tutelata dall’articolo 34 della Costituzione.
Qui il liberalismo di Gentile e Lombardo Radice che pare di fatto potere convivere con quegli elementi che invece alludono alla trasformazione del fascismo in un’autocrazia.
Più indicativo infatti è il contenuto di questi programmi, soprattutto per quanto riguarda la storia, e soprattutto tenendo conto di come in generale occorre concentrarsi sul progetto pedagogico che veniva conferito all’insegnamento della storia già in epoca liberale dall’Ottocento in poi.
La storia nell’età delle nazioni e degli imperi deve contribuire a creare la cittadinanza come una sorta di statuto morale.
Ecco qui la prima analogia con quello che accade oggi. Un approccio molto simile lo troviamo in Loredana Perla e Ernesto Galli della Loggia, coordinatrice generale e coordinatore per la storia della Commissione di revisione delle Nuove indicazioni nazionali.
L’invenzione della tradizione
Cosa sono le Indicazioni nazionali? Una sorta di carta costituente per la scuola. Hanno sostituito da più di vent’anni i programmi. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha deciso di rivedere quelle del 2012, ed è da poco uscita la prima bozza.
Ecco un brano delle pagine di questa bozza dedicate alla storia.
La storia, come si mostra nei grandi testi che l’hanno raccontata, intesa cioè come indagine e ragionamento intorno agli avvenimenti, al loro svolgimento, alle forze che li hanno prodotti e alle qualità dei loro protagonisti, si è sempre accompagnata anche a un giudizio morale su quanto era oggetto del suo racconto.
In questo modo essa ha rappresentato una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male.
Come può avvenire tutto questo?
Oggi come allora: attraverso una pedagogia essenzialmente nazionalista. Su questa funzione dell’insegnamento, soprattutto della storia, si può leggere una vasta bibliografia, ma un ottimo testo recente e riassuntivo è quello di Anna Ascenzi, Metamorfosi della cittadinanza. Studi e ricerche su insegnamento della storia, educazione civile e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento, del 2009.
Ascenzi ricorda come lo studio della storia, nei nuovi programmi del 1923, viene fatto partire dalla terza elementare, con questo indirizzo:
Avviato con lo studio dei fatti più recenti, l’insegnamento della storia in terza elementare era incentrato sui «racconti bene ordinati di storia italiana, dal 1848 al 1918», e sulla «lettura dei più significativi documenti (proclami, lettere e ricordi di martiri, ordini del giorno di condottieri)».
Nell’ambito di quelle che erano considerate dai programmi del 1923 le «occupazioni intellettuali ricreative» per gli alunni della medesima classe, si proponevano altresì «cicli di letture del maestro per destare e sviluppare la coscienza storica nazionale. Vite di grandi uomini. (Non mancheranno le vite di Garibaldi e di Battisti)».
Ecco qui saltare all’occhio il principio di didattica della storia incarnato dalle storie esemplari nazionali e patriottiche. Di nuovo ritroviamo l’approccio di Loredana Perla e Ernesto Galli della Loggia, autori a quattro mani di un pamphlet intitolato Insegnare l’Italia, testo del 2023, e matrice delle Indicazioni nazionali stesse. Citiamo un brano paradigmatico:
Nella scuola primaria, insomma, sarebbe assai meglio cominciare lo studio della storia con le vicende storiche italiane.
Ho detto non a caso storiche italiane, al plurale, e non già storia d’Italia, perché penso che a questo livello iniziale la storia debba essere presentata al bambino essenzialmente come una serie di racconti di singoli episodi. Anche cronologicamente slegati tra di loro, se si vuole, ma capaci di colpire la sua immaginazione (qualcosa di simile sia pure molto alla lontana ai racconti mensili di Cuore).
Dalla bozza delle Indicazioni nazionali:
Anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa. E cioè un insegnamento/apprendimento della storia che metta al centro la sua dimensione narrativa in quanto racconto delle vicende umane nel tempo.
La dimensione narrativa della storia è di per sé affascinante e tale deve restare nell’insegnamento, svincolato da qualsiasi nozionismo così come da un inutile ricorso a “grandi temi”, disancorati dall’effettiva conoscenza degli eventi.
Non è pertanto necessario che i discenti imparino tutto ciò che di più o meno notevole è avvenuto in ciascuna epoca, bensì che apprendano quanto è stato davvero determinante, in primo luogo nella vicenda storica italiana.
Non è difficile notare le somiglianze. E non è difficile notare le somiglianze anche per quello che riguarda la storia greca e romana, che per Giuseppe Lombardo Radice come per Galli della Loggia occorre studiare attraverso esempi di storie di eroi e gesta prese nella loro funzione anticipatrice della cultura occidentale. Un’invenzione della tradizione, non importa quanto generica o propagandistica o encomiastica: una specie di logica da Inno di Mameli applicata alla didattica.
Altrettanto se non più strumentale sarà per un’educazione patriottica la storia del Risorgimento. Lo spazio che nei programmi del 1923 e nella bozza delle Indicazioni nazionali del 2025 viene dato al processo di unificazione nazionale è tanto ampio che sembra non temere nemmeno le accuse di sproporzione. Italia e patriottismo ovunque.
E dal punto di vista didattico, ancora di più per il Risorgimento, il metodo privilegiato Lombardo Radice resta quello imperniato sulle biografie e sui racconti storici, giudicato il più adatto all’intelligenza dei bambini. Ma anche oggi la visione didattica non sembra voler essere differente.
Libri patriottici
Ma i programmi e le Indicazioni nazionali non bastano a orientare l’insegnamento. Come riconoscono tutti gli storici finora citati e come è evidente a chiunque sia nella scuola, i programmi (e anche se non esistono più…), spesso e ancora li fanno i libri di testo.
Per questo è significativo ripercorrere i lavori della Commissione sull’editoria che tra il 1924-25 accompagnò l’attuazione dei programmi di Lombardo Radice. Nonostante gli sforzi degli editori di riposizionarsi nel campo patriottico-fascista, i desideri governativi chiedevano di più.
Di nuovo Anna Ascenzi coglie il punto:
L’ideale patriottico e l’educazione al sentimento nazionale si configuravano, tanto nei giudizi espressi sui singoli libri di testo, quanto nella relazione riassuntiva di Giuseppe Prezzolini, come uno dei principali fattori discriminanti – per quel che atteneva ai contenuti e ai modelli formativi – nella selezione delle opere sottoposte al vaglio della Commissione centrale.
Di qui la polemica nei riguardi di tanti, troppi «componimentini [...] sul pacifismo e sulla fratellanza dei popoli» e sulle idee – qua e là riscontrabili in tante pagine delle letture storiche per le classi elementari superiori – «che rispondono alle correnti politiche di trent’anni fa»; di qui anche la precisazione – polemicamente rivolta ad autori ed editori – che per formare il sentimento nazionale nelle nuove genera- zioni non bastava «qualche inno patriottico», e non era neppure sufficiente «disegnare sulla copertina un giovinetto che saluta romanamente!»
La svalutazione dei “componimentini sul pacifismo e sulla fratellanza dei popoli” sembra proprio ricordare gli editoriali di Galli della Loggia, quelli che guardano con favori i venti di guerra ma anche quelli che semplicemente vedono nei fantasmi del globalismo e della scuola democratica i mali non solo dell’istituzione scolastica ma della stessa storiografia novecentesca e contemporanea.
Sul Corriere il 17 gennaio elogia l’intento del ministero di rivedere le Indicazioni nazionali in senso antimondialista e il 29 gennaio sempre sul Corriere pubblica un editoriale intitolato Insegniamo la storia. Ma vera, in cui se la prende con chi ha avuto e ha una prospettiva non eurocentrica.
Nella bozza delle Indicazioni nazionali questa prospettiva è scolpita alla prima riga dedicata alla storia con l’affermazione perentoria messa a incipit: “Solo l’Occidente conosce la Storia”.
Qualche anno fa in una conferenza Galli della Loggia indicava esplicitamente il suo obiettivo polemico nel braudel-marxismo, uno strano mostro a due teste, quella dello storico Fernand Braudel attaccata a quella di Karl Marx,che però guardavano entrambe oltre le colonne d’Ercole, con grave danno di chi li seguiva.
La scuola di Gentile non possiamo ridurla a una scuola fascista, la scuola di Valditara non possiamo ridurla a una scuola postfascista, nonostante entrambi siano ministri di governi che dichiarano la loro ideologia senza infingimenti: stiamo parlando invece di una ideologia liberal-nazionalista che ha continuità che sono profonde e di lunghissima durata.
Non sappiamo se le attuali Indicazioni nazionali verranno approvate o se le critiche che stanno arrivando da larghissimi settori della scuola e dell’università faranno desistere o arretrare il ministero; ma soprattutto non sappiamo che impatto avranno sulla vita della scuola. Insomma non conosciamo cosa accadrà alla scuola dal 2026 dopo questa esplicita torsione in senso nazionalistico voluta da Valditara-Galli della Loggia-Perla-Meloni.
Quello che sappiamo invece è cosa avvenne dal 1926 in poi. Tutti i ministri che succedono a Gentile manifestano con orgoglio la continuità con Gentile, ma nei fatti eliminano qualunque maschera della loro adesione assoluta al fascismo.
L’ideologia nazionalista e l’ideologia fascista da metà anni Venti diventa una cosa sola.
I libri di testo di storia, geografia, lettura, economia e diritto per le scuole elementari e per i corsi integrativi di avviamento professionale rispondono con gradi di obbedienza sempre più marcati “alle esigenze storiche, politiche, giuridiche ed economiche affermatesi dal 28 aprile 1922 in poi”, come recita la relazione Romano del 1928 sui libri di testo (e in realtà questo è vero in parte già dalle commissioni del 1923).
Fascistizzare la scuola è un’esigenza divenuta ormai prioritaria e indilazionabile per il regime. Il liberalismo ha lasciato campo totalmente libero al nazionalismo – anche perché forse non era molto altro che nazionalismo? – e quindi al fascismo.
L’attivismo normativo
Un ulteriore elemento di affinità tra la scuola di quei primi anni venti e la scuola dei nostri anni venti è quella normativa. Gli storici citati convergono su un aspetto che spesso non viene distinto.
La pletora normativa che accompagna e segue la riforma Gentile è fatta soprattutto da atti amministrativi e circolari, che costituiscono una sorta di “normativa sotterranea” che, scrive Galfré, “più che sancire dei divieti, spesso non faceva che richiamare i singoli, presidi e insegnanti, alle loro responsabilità, trasformandoli così nei censori della loro stessa libertà. Non di rado, quando si parla di libertà didattica, si dimenticano le molte e diverse pressioni che si concentrarono sull’insegnante all’interno della società in via di fascistizzazione”.
Non si può dire con sicurezza che la scuola post-gentiliana fosse investita dallo stesso spirito di fascistizzazione (in realtà è un processo palpabile, continuo, ineludibile), sicuramente veniva investita da uno spirito di pedagogia nazionalista.
L’instancabile attivismo normativo del ministro Valditara assomiglia proprio a quello che accadeva nella fase post-gentiliana: il varo di documenti molto dibattuti, come le nuove linee guida per l’educazione civica o il codice etico per i docenti o la bozza delle nuove Indicazioni nazionali è accompagnato da decretazione per piccoli casi, da piccole e piccolissime innovazioni normative (pensiamo alla circolare che proibisce lo schwa e l’asterisco nella documentazione ufficiale).
Insieme alla gran messe di dichiarazioni istituzionali di Valditara tutto questo va a puntellare la vita dell’istituzione scolastica con una cadenza praticamente quotidiana e tutto il dibattito che ne consegue.
Riuscire a orientarsi in questa nebulosa è difficile oggi, doveva essere molto difficile anche allora.
Ancora più difficile doveva essere riconoscere il confine della libertà garantito o eroso dalle istituzioni sempre più fascistizzate.
L’attacco alla libertà di associazione e alle organizzazioni sindacali avviene anche prima del 1925-26, come ricostruisce Antonio Santoni Rugiu già nel 1959 ((Il professore nella scuola italiana).
I presidi che già nel 1923 avevano assunto con decisione questo ruolo di controllo ideologico sugli insegnanti, segnalando per esempio i docenti antifascisti.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione viene spogliato di ogni potere deliberativo e ridotto a mero organo consultivo se non simbolico: una riforma che ancora oggi pesa. Ma soprattutto, nota Santoni Rugiu:
La facoltà di critica degli insegnanti organizzati venne rimessa alla discriminazione delle autorità scolastiche, il cui compito era di richiamare giornalmente gli insegnanti alla loro responsabilità e solo eccezionalmente consentire l’accoglimento di proteste, purché non provenissero da organizzazioni sindacali o didattiche immeritevoli di parlare a nome dei colleghi, sul che dovevano decidere i provveditori.
Nell’analisi di Santoni Rugiu viene mostrato come i principi ispiratori della riforma siano: disciplina, gerarchia, sottomissione all’autorità. Gli elementi da eliminare: lo spirito di autonomia e l’innovazione didattica.
Vengono invece abolite le varie forme di rappresentanza dei docenti nei consigli e nelle deputazioni provinciali, nelle commissioni per i ricorsi.
In più, l’autorità del preside viene aumentata e trasformata di fatto nella pura vigilanza degli insegnanti, dentro e fuori la scuola; mentre la formazione degli insegnanti viene improntata secondo un’impostazione idealistica ispirata alla filosofia gentiliana, ossia un minestrone di attivismo, spiritualismo, autoritarismo, obbedienza al regime.
Quanta di questa roba ha avuto un esito di lunghissima durata, esplicitamente, implicitamente?
Oltre ai sindacati, anche le organizzazioni degli insegnanti, dall’Unione magistrale o la fin allora battagliera Fism, non soltanto vengono sciolte, ma non si leva quasi nessuna forma di protesta. Ma la fascistizzazione degli insegnanti va anche oltre gli obiettivi di Gentile.
L’inquadramento dei docenti nelle organizzazioni del regime dal 1925 procede spedito.
La Confederazione fascista della scuola svolge una funzione di primissimo piano. Il 5 dicembre 1925 si svolge il primo congresso nazionale. Diventa chiaro subito il modello di quello che avverrà negli anni successivi: partecipano ottomila insegnanti, la regia del congresso è stata attentamente curata per mesi attraverso una propaganda capillare nelle scuole. Il primo novembre la rivista La cooperazione della scuola scrive:
Le leggi fascistissime andranno prossimamente in Senato, siamo certi che l’alto consesso vorrà approvarle.
Alla corporazione al ministero della Pubblica istruzione incomberà tra poco uno dei più alti e tremendi compiti: la loro energica e intelligente attuazione.
Bisogna sì evitare alla scuola ogni scossa pericolosa, ma bisogna pur liberare la scuola dai pochi elementi assolutamente refrattari al clima spirituale e morale della rivoluzione fascista.
L’opera richiede fermezza e coraggio, richiede inoltre grande onestà e sicura avvedutezza.
Oltre ai sindacati, anche le organizzazioni degli insegnanti, dall’Unione magistrale o la fin allora battagliera Fism, Federazione italiana scuole medie, non soltanto vengono sciolte, ma non si leva quasi nessuna forma di protesta.
Gli insegnanti si adeguano al regime, come la maggioranza schiacciante di tutti gli altri italiani. Il corpo liberale e democratico delle istituzioni è stato sottoposto a un processo di osteoporosi, imprimergli delle fratture violente non sarà difficile.
Da leggere su Appunti
Una settimana di dazi: cosa abbiamo imparato
Il consigliere Peter Navarro dice una cosa molto diversa da Trump: sostiene che i dazi servano per costringere gli altri Paesi a ridurre le proprie barriere tariffarie e non tariffarie, cioè i dazi e i regolamenti che limitano le esportazioni americane.





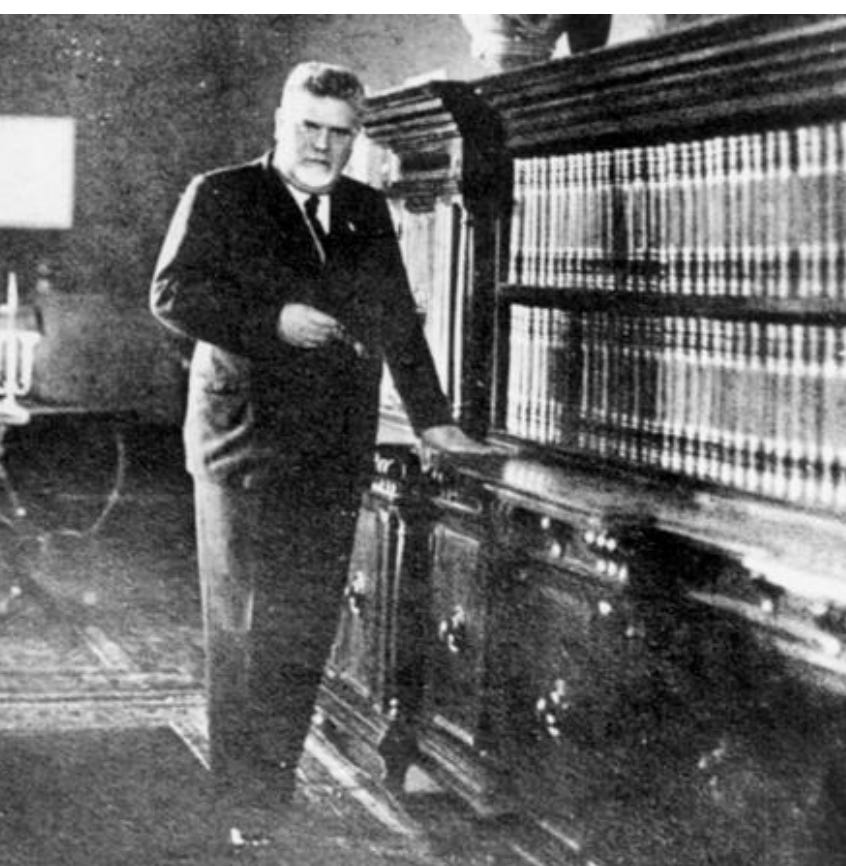


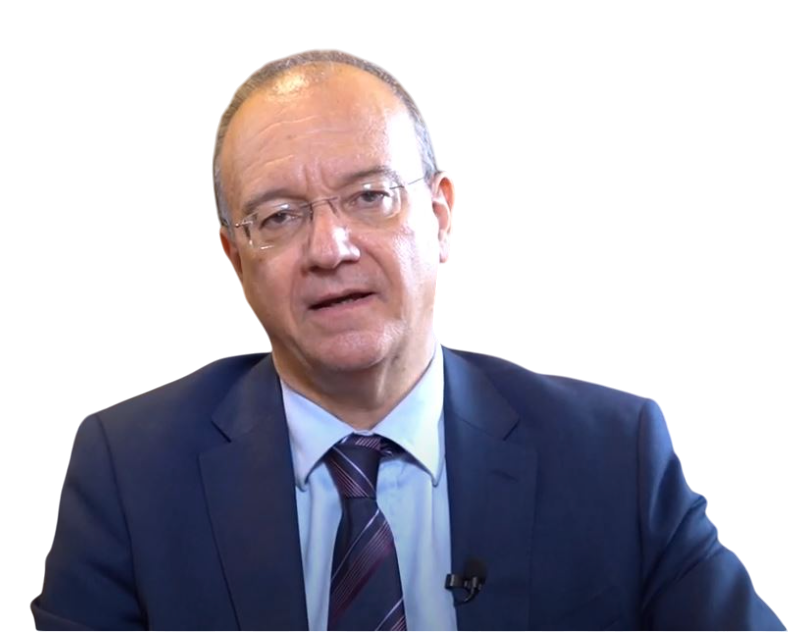
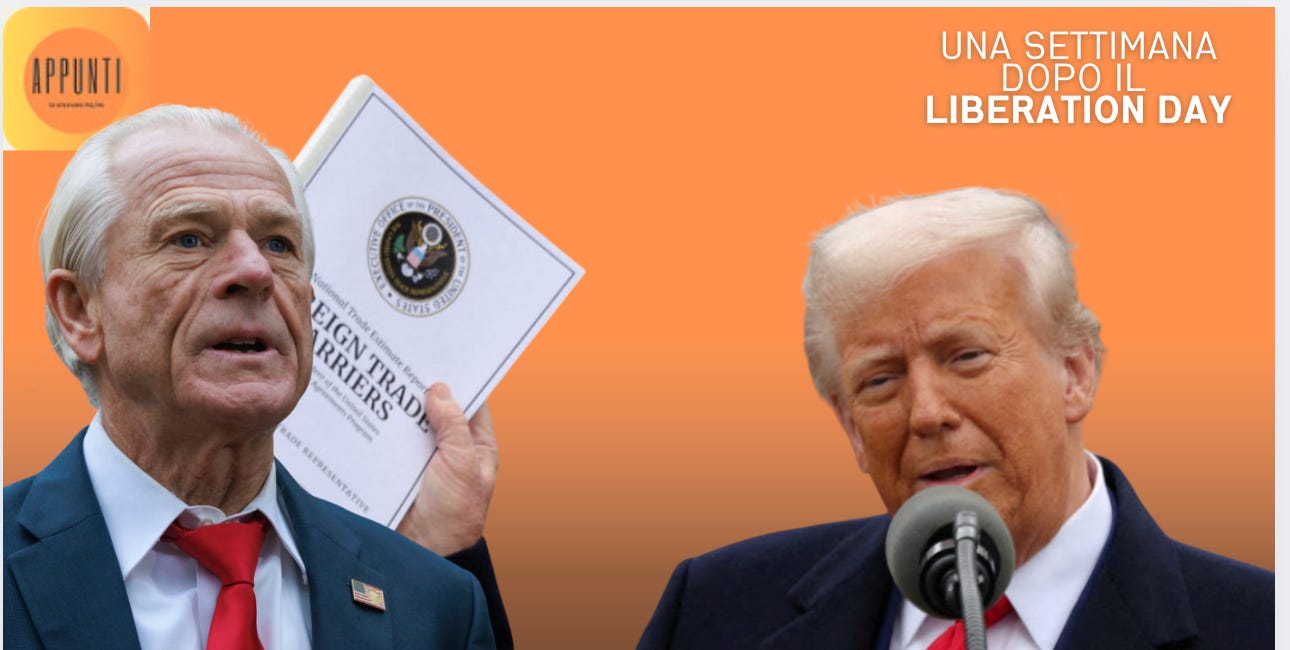


Grazie di questo bell'articolo. Personalmente credo che il problema sia ancora più grave. Lo spirito di obbedienza ad esempio è considerato un valore da molti oggi - forse anche in contrasto al menefreghismo e all'individualismo che hanno devastato la cultura italiana per più decenni -.
Non serve ripetere (o forse sì...) che non c'è mai stata una reale presa di coscienza e di distanza (dalla mentalità coltivata) dal fascismo. Anche nella scuola. Tanti miei insegnanti negli anni Ottanta davano per scontato lo spirito di obbedienza. Era un valore, riconoscere chi sta sopra di te. Lo si distingueva dal servilismo, certo, bella giustificazione. Quindi sì, concordo pienamente: gli effetti del fascismo sulla scuola sono di durata molto lunga.
Educare alla libertà e contemporaneamente alla responsabilità e al rispetto dell'alterità è complesso, già verso una persona singola, tanto più verso un gruppo e tanto, tanto più verso un'intera società. Sarebbe l'essenza della democrazia. Io non l'ho ricevuto a scuola né l'ho visto o vissuto in tanti rapporti sociali.
Quello che a me è sempre pesato in tutti gli aspetti della vita sociale è l'ambiguità, la famosa distanza tra il dire e il fare. Che è una terribile conseguenza del fascismo ed è proliferato senza misura.
Sul piano personale si può decidere come si vuole essere e di chi si vuole avere fiducia.
Ma il problema è sul piano sociale e su quello delle strutture. Devono esistere strutture di controllo democratico, che permettano il confronto di posizioni diverse, posizioni che devono avere effetto diretto sull'agire. Non può essere solo la stampa, o i partiti, o i "movimenti" il luogo il cui esprimere la propria posizione. La loro funzione è quella di esprimere, non di agire.
Le strutture di controllo democratico dovrebbero cominciare dal basso, perché è lì che ci si allena alla prassi della democrazia. Al processo di prendere decisioni, al compromesso, alla pluralità, alle conseguenze del proprio operare sugli altri. Dovrebbero esistere anche nelle associazioni, nella scuola appunto, nelle strutture di lavoro, dappertutto.
Questo secondo me manca, anzi credo che si sia sgretolato sempre più nei decenni. O forse insieme al muro di Berlino. Oppure ci abbiamo rinunciato? Per evitare conflitti. Per semplificare le cose. Per mille motivi. Non lo so, dovrei fare una ricerca più approfondita.
La mia opinione è che un dirigente (o un suo gruppo di lavoro) può fare delle proposte, anche sbagliate. Ma deve renderne conto, prima o dopo. Non solo al proprio superiore; anche agli organi che sottostanno, visto che siamo in una democrazia; i cui membri non possono essere mai al 100% d'accordo.
Non possiamo perdere questa fiducia. Non dobbiamo. Sarebbe già un'adesione al fascismo.
E' vero che gli organi di controllo democratico funzionano male, a volte sono svuotati della loro funzione, è anche vero che la nostra società ha perso già la dimensione democratica per sfiducia, per convinzione, per immobilità, per individualismo, ma lo stesso:
la democrazia non è fatta da brave persone, da persone in gamba, da persone che pensano al benessere di tutti. La democrazia è un SISTEMA di governo, un sistema complesso che non si eredita. Forse abbiamo perso l'allenamento, dobbiamo solo ricominciare. Non seguendo il "maestro" di turno, quello che ha qualcosa da dire. Ma mettendoci in gioco, ognuno di noi. Sbagliando e riprovando. Vivendo sulla propria pelle che decidere per altri e con altri non è semplice, che si sbaglia ma si impara, che il pragmatismo e l'idealismo devono convivere.
Un articolo molto interessante e purtroppo c'è da dire che parlare di istruzione dovrebbe essere un argomento da trattare da tutti perché tocca le basi di ogni società . Tutti ci lamentiamo della bassa formazione e del fatto che le nuove generazioni ( ma anche le vecchie) non hanno una preparazione e non hanno conoscenza della storia . Nell'articolo c'è un passaggio dedicato proprio alle modalità di presentazione della storia e soprattutto della storia d'italia da cui traspare l'importanza dell'approccio del metodo da utilizzare nella scuola primaria. È lì che parte la formazione e l'approccio delle menti giovani. Non possono essere solo cronologia di date ed eventi ma anche "morale costituzionale " nel senso che vanno ribaditi i principi fondanti di un popolo o di tante popolazioni che sono unite in unica nazione ed oggi anche il valore aggiunto di essere parte di una comunità più grande l'Europa. Occorre ricordare quello siamo stati :piccoli e litigiosi.
Purtroppo non bastano le linee guida, ci sono i testi e quindi un'editoria che va per conto suo. C'è, quindi, la questione della validità dei contenuti la scelta dei testi e la variabile indipendente degli insegnanti.
Credo che la conoscenza della storia " raccontata" in modo semplice ma coinvolgente potrebbe preparare ad affrontare con spirito critico o almeno con attenzione la vita quotidiana fatta di relazioni continue che meritano il rispetto di tutti.