Abolire il quorum è giusto (ma non per le ragioni che pensate)
A una settimana dal referendum, è tempo di bilanci: gli argomenti a difesa di astensione e quorum sono deboli e anti-democratici
Il contrario di avere il diritto di voto non è “non poter votare”, ma è “non poter decidere se votare oppure no”. Altrimenti si dovrebbe concedere che in un regime dittatoriale dove l’astensione è vietata per legge, come in Corea del Nord, c’è il diritto di voto
Maurizio Mascitti
Dopo il fallimento dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza, affossati da un’affluenza alle urne del 30 per cento, l’ex presidente dei Radicali italiani Marco Cappato si è esposto sui social per chiedere di abolire il quorum ai referendum popolari:
Per carità, non andare a votare è perfettamente legittimo. Però non è che chi non va a votare deve poter decidere per chi si fa lo ‘sbattimento’ di andare a votare. È arrivato il momento di abolirlo, il quorum. Era stato fissato in Costituzione in un’altra epoca, dove a votare ci andavano tutti. Non è più così; allora facciamo che chi va a votare decide. Decide chi vota.
Cappato ha anche promosso la raccolta firme digitale in favore di una legge di iniziativa popolare che sostituisca il comma incriminato dell’art. 75 della Costituzione (questo) con un nuovo comma; cioè uno che non menziona la “partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto” tra i requisiti di approvazione di un referendum.
La tesi di questo articolo è che la proposta di Cappato – abolire il quorum – è assolutamente giusta e condivisibile, ma non per le ragioni che vengono tirate fuori di solito; e quindi neanche per quelle citate dall’esponente dei Radicali.
Non passeremo in rassegna i dati sull’affluenza di tutti i referendum abrogativi dal 1975 in poi – che potete già trovare qui. Non si vuole sostenere, come fa Cappato, che il quorum ai referendum popolari va abolito perché si tratta di un dispositivo concepito in un’altra epoca, in condizioni storiche diverse e con un’affluenza maggiore ai seggi.
E non importa se ci sono altre democrazie, come la Svizzera, che svolgono già i referendum senza quorum.
C’è bisogno di una critica più radicale: il quorum va abolito perché non ha nessuna giustificazione convincente per esistere.
Le giustificazioni del quorum
Si tratta di una critica concettuale, che prende le mosse dalla domanda inversa: perché dovrebbe esserci un quorum per i referendum popolari?
Ogni volta che pongo a qualcuno questa domanda, generalmente mi vengono date due risposte che possiamo riassumere nel modo che segue:
Il quorum serve perché…
Garantisce che l’abrogazione parziale o totale di una legge avvenga solo se esiste una partecipazione ampia degli aventi diritto. Senza partecipazione ampia non si avrebbe un vero processo democratico.
Riduce il rischio che delle minoranze, piccole ma organizzate, tentino di modificare o cancellare leggi approvate a larga maggioranza parlamentare.
Queste non sono certo le uniche risposte che mi vengono date, ma sono le più ricorrenti. Quando si vuole difendere l’esistenza del quorum si usa sempre una qualche versione di (1) o di (2) come argomento principe.
Il problema è che sono entrambe discutibili, per non dire fragili.
La prima risposta ha due grossi limiti. Innanzitutto, assume erroneamente che l’astensione non sia una forma di partecipazione.
L’idea implicita nel quorum è che la democrazia attiva si esprima solo votando, ma non è così. Avere il diritto di fare qualcosa – in questo caso di votare – significa anche avere la possibilità di non esercitarlo, quel diritto.
Quando scelgo di non andare a votare sto esercitando una mia libertà, la libertà di non usufruire di un diritto. E questo non mi rende ‘meno’ democratico di qualcuno che invece sceglie di compilare la scheda. Solo un’idea romantica e un po’ adolescenziale di democrazia potrebbe farci pensare diversamente.
Il contrario di avere il diritto di voto non è “non poter votare”, ma è “non poter decidere se votare oppure no”. Altrimenti si dovrebbe concedere che in un regime dittatoriale dove l’astensione è vietata per legge, come in Corea del Nord, c’è il diritto di voto.
A corollario, questo significa anche che di per sé l’astensione non è un fatto anti-democratico. Siamo abituati a pensarlo perché viviamo in un paese dove, nelle ultime decadi, sta progressivamente aumentando il tasso degli astenuti.
Ma questo non deve portarci a confondere una questione concettuale – l’astensione come eguale forma di partecipazione – con una contingenza storica – la troppa astensione come un problema sociale.
Sono due cose diverse, e rimangono tali.
La partecipazione e gli astenuti
Arriviamo quindi alla prima grande obiezione contro il quorum: anche quelli che si astengono hanno partecipato in qualche modo al voto; e lo hanno fatto esprimendo la loro preferenza di non pronunciarsi. Questo ovviamente comporta delle responsabilità.
Quando si obietta con la solita iperbole “E se vanno a votare soltanto in dieci? Decidono loro per tutti gli altri?”, la risposta non può che essere una: sì, è giusto che siano quei dieci a decidere per tutti gli altri, perché sono proprio gli “altri” ad averglielo concesso, scegliendo di non recarsi a votare. È la responsabilità che segue dalla scelta di non esercitare un diritto.
Non c’è nulla di strano; non lasciamoci scoraggiare dalla forza emotiva dell’iperbole.
C’è inoltre un aspetto di arbitrarietà nella (1). Come si decide quanto è ampia la partecipazione? Perché non fissare il quorum a 55 per cento, o a 66 per cento?
La Costituzione stabilisce che è sufficiente la maggioranza semplice degli aventi diritto; ma il giudizio su quanto sia ampia una partecipazione è totalmente soggettivo e legato al momento storico (come lo era il giudizio di chi ha scritto la Costituzione).
Oggi facciamo fatica a immaginarci un referendum popolare che raggiunga il 51 per cento di affluenza, ma un referendum che negli anni Ottanta avesse raggiunto quella percentuale sarebbe stato definito una disfatta e un crollo storico nell’affluenza.
Partecipazione “ampia”, quindi, non vuol dire nulla. È un giudizio arbitrario e legato alla contingenza; così come la soglia del quorum.
Il potere delle minoranze
Arriviamo quindi alla seconda argomentazione, quella che sostiene che il quorum impedisce alle minoranze organizzate di modificare o cancellare leggi approvate a larga maggioranza parlamentare. È un’osservazione sicuramente più cogente della (1), ma anche qui ci sono dei problemi.
Anzitutto, l’argomento sottovaluta il potere reale dei referendum popolari, che in Italia sono esclusivamente abrogativi.
Non consentono cioè di introdurre nuove norme, né di modificarne parzialmente altre: permettono solo di cancellare interamente (o per segmenti chiari) una disposizione già esistente.
Questo vincolo rende già molto difficile, per chi promuove un referendum, orientare l’opinione pubblica verso soluzioni complesse o manipolatorie: la portata dell’intervento è limitata, binaria, non plasmabile come un emendamento parlamentare.
In secondo luogo, l’idea che siano le minoranze organizzate a utilizzare i referendum per imporre i propri interessi è scarsamente supportata dai fatti.
Nella prassi politica, italiana e non solo, i gruppi di pressione più influenti non si affidano allo strumento referendario per orientare l’agenda legislativa.
Al contrario, operano all’interno delle sedi istituzionali, tramite attività di lobbying, pressioni su singoli parlamentari, relazioni consolidate con i partiti, e una presenza capillare nei processi di produzione normativa.
Questo vale sia per le grandi lobby economiche e industriali, come banche, assicurazioni e multinazionali, sia per corporazioni più tradizionali e radicate nel territorio, come i tassisti, i balneari o gli ordini professionali (pensate soltanto all’influenza che queste piccole corporazioni hanno sui gruppi dirigenti dei partiti di maggioranza, come la Lega).
La ragione per cui questo accade è semplice: il referendum è uno strumento farraginoso, costoso e imprevedibile; oltreché limitato per natura, come si diceva prima.
Raccogliere centinaia di migliaia di firme, superare il vaglio della Corte costituzionale, e infine convincere una parte significativa dell’elettorato ad andare alle urne a votare per la propria causa è un percorso molto più complesso e incerto rispetto a una trattativa riservata con un sottosegretario, o a un emendamento inserito di soppiatto nella legge di bilancio.
Infine, anche ammesso che esista il rischio di una manipolazione referendaria da parte di piccoli gruppi, ci sono strumenti molto più coerenti del quorum al voto per contenerlo.
Ad esempio, se si cancella il quorum al voto, si potrebbe innalzare il numero di firme necessarie per proporre un referendum, soprattutto in epoca di raccolta digitale, dove l’accesso è diventato più rapido e meno selettivo.
Rafforzare la soglia d’ingresso – sempre un quorum, ma di tipo diverso – garantirebbe una selezione iniziale più rigorosa, evitando l’abuso dello strumento. Ma una volta superata quella soglia, la cittadinanza dovrebbe poter esprimersi senza condizionamenti indiretti come il quorum al voto, che premia l’astensione strategica.
La competizione distorta
Perché ricordiamoci che l’astensione strategica, garantita dal quorum, non è soltanto odiosa per la sua natura distorsiva: chi vota no è avvantaggiato rispetto a chi vota sì. Ma è altrettanto detestabile perché è la vera nemica di ogni serio dibattito pubblico sui quesiti, qualunque essi siano.
In un sistema che premia il non voto, chi è contrario a un quesito referendario non ha alcun incentivo a confrontarsi nel merito, a spiegare le proprie ragioni, a entrare nel vivo del conflitto democratico. Gli basta essere assente, delegittimare la consultazione e attendere che il silenzio faccia il suo corso.
Il risultato è che non si forma una vera opinione pubblica, non si chiariscono le poste in gioco, e la cittadinanza viene privata dell’occasione di confrontarsi su scelte cruciali. Abolire il quorum non è solo giusto, ma necessario.
Da leggere su Appunti
Appunti di Geopolitica - Episodio 0: Le mille idee di Polonia
Il destino della Polonia è oggi nelle mani più di Washington, di Berlino, di Londra e di Parigi - ma anche di Mosca e Kiev - che in quelle di Varsavia
Qui la puntata di Otto e mezzo su La7 dove ho presentato il libro
MUSK TALKS - in diretta su Substack
Mercoledì 21 maggio ore 17 - Musk e il nuovo potere digitale - Con Laura Turini e Stefano Feltri
Martedì 27 maggio, ore 17 - Musk e l’ideologia del tecno-capitalismo - Con Gloria Origgi e Stefano Feltri
Mercoledì 4 giugno, ore 17 - La crisi della democrazia nel tempo di Musk - Con Mattia Diletti e Stefano Feltri
Martedì 17 giugno, ore 17 - Musk e l’ascesa della tecnodestra - con Vincenzo Sofo (autore di Tecnodestra per Paesi edizioni)
Martedì 24 giugno, ore 17 - Musk, i satelliti e la geopolitica dello spazio - con Frediano Finucci (autore di Operazione Satellite per Paesi edizioni)
Dal vivo:
Sabato 31 maggio, ore 15, al Festival dell’Economia di Torino, al Circolo dei lettori: Contro Elon Musk - con Marc Lazar e Stefano Feltri, coordina Eva Giovannini
Giovedì 19 giugno, ore 18: A Roma, alla Libreria Testaccio, piazza Santa Maria Liberatrice 23, con Carlo Tecce
Per info su presentazioni, interviste, speech: appunti@substack.com (non sono in grado di organizzare altre cose fuori Roma, quindi non offendetevi se declino inviti a festival o presentazioni che richiedono trasferte)
Da leggere su Appunti
Chi osa ancora volare con un Boeing?
Cambiare la cultura aziendale di una impresa grande e complessa è difficilissimo, farlo mentre si cerca di salvarne la redditività dal calo di fiducia di clienti e investitori è ancora più arduo






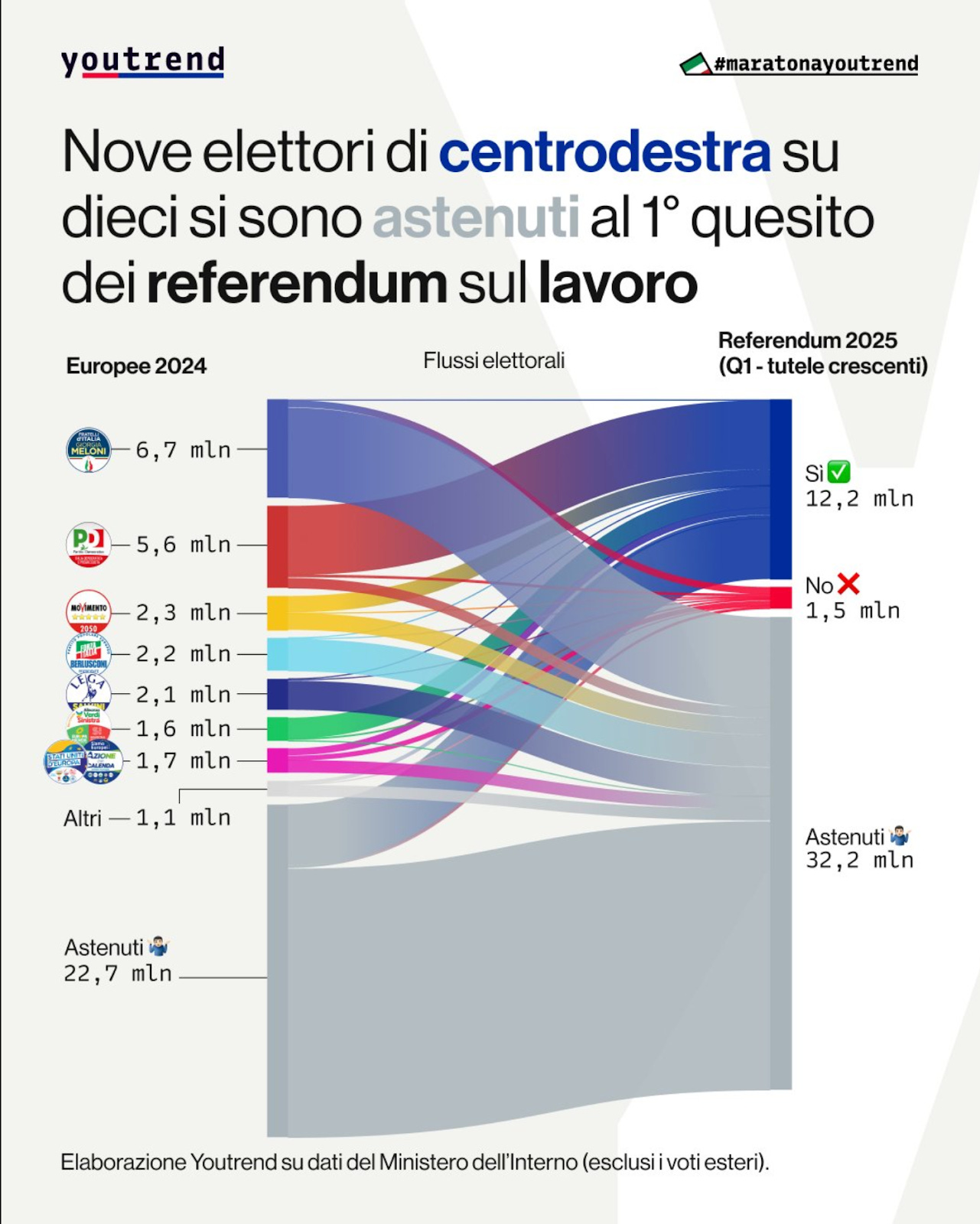







Articolo interessante. Per me il principio costituzionale del quorum mantiene un senso per il punto 2 citato nell'articolo. L'unica modifica che farei sarebbe nel fissare la soglia del quorum alla metà della percentuale di votanti delle ultime elezioni politiche nazionali per il rinnovo del Parlamento. E' infatti evidente come ormai la crescente massa di "turisti della democrazia" che non vota risulti decisiva nel far fallire qualunque referendum possa venire proposto. Fermo restando il diritto alla astensione, penso che il voto sia anche un dovere civico perchè se la sovranità appartiene al popolo, quest'ultimo ha il diritto-dovere di esercitarlo.
Il problema non è il quorum ma i 500.000 voti per promuovere i referendum, che sono pochissimi. Gli ultimi referendum proposti sono stati sempre referendum stupidi, con temi poco coinvolgenti e su cui pochissimi ci capiscono, ci fosse stato un referendum sul divorzio oggi probabilmente avrebbe una partecipazione simile a quella dell'epoca. Ma se facciamo i referendum su, come diceva Gaber, "dov'è che i cani devono pisciare" allora chiaro che ci vanno in pochi. La nostra costituzione, a differenza di quella Svizzera immagino, vede il referendum come una cosa eccezionale (per fortuna direi, visto il livello culturale medio degli italiani) infatti vi sono forti limiti agli argomenti che si possono sottoporre a referendum. Se vogliamo trasformarlo in uno strumento per aiutare il parlamento a legiferare allora bisogna cambiare lo spirito della costituzione su questo tema. Dopodiché attenzione, perché stiamo ancora pagando i danni del referendum sul nucleare...